L’eterna invenzione dell’altro da sé

Passato&Presente. Una riflessione sui trascorsi coloniali italiani, tra dopoguerra e attualità. Dalla perdita del dominio africano fino agli sgomberi di piazza Indipendenza: è possibile una rimozione?
L’Italia ha davvero rimosso il passato coloniale? In questo articolo, proveremo a dare una risposta, sebbene parziale. Due saranno i percorsi per ridiscutere la rimozione: uno sincronico, che interroga il dopoguerra; l’altro diacronico, che legge la condizione postcoloniale guardando al passato. L’anno da cui cominciare è il 1941, quando l’Italia perde l’Africa Orientale Italiana. Due anni dopo è la volta della Libia. Con il trattato di Parigi (1947) si ufficializza tale condizione.
I tentativi di riavere le colonie sono molteplici: con il memorandum redatto da Cora e Cerulli, nel 1948; con interventi dagli scranni delle Nazioni Unite; con pubblicazioni e congressi dei profughi d’Africa; con azioni di vari schieramenti politici, della diplomazia internazionale, di alcuni studiosi (ministero dell’Africa Italiana, Istituto per l’oriente, ecc.). Si giunge all’accordo Bevin-Sforza, siglato in segreto il 6 maggio 1949, tra i ministri dell’interno inglese e italiano per l’attribuzione, su base coloniale, delle ex-terre d’oltremare. Accordo che dovrebbe essere approvato in sede Onu. Ma Haiti vota contro e quindi fa mancare il quorum.
Con una relazione scomposta, l’Italia chiede, allora, l’indipendenza della Libia e dell’Eritrea. L’Assemblea generale approva due risoluzioni che recepiscono tale istanza. Così, la Libia diventa indipendente, il 24 dicembre 1951, e l’Eritrea una zona federata dell’Etiopia, il 15 settembre 1952. La Somalia è affidata all’amministrazione fiduciaria italiana dal 1 aprile 1950 e per un decennio. Che cosa succede, nel frattempo, alla cultura italiana? L’imponente archivio di immagini, pratiche e discorsi coloniali si rompe definitivamente nel 1947? La risposta è negativa.
Cristina Baldassini, nel suo L’ombra di Mussolini, ha dedicato un capitolo a studiare la memoria del colonialismo sulle colonne di riviste popolari come Epoca, Oggi e Il Borghese. «Il ricordo della conquista d’Abissinia – scrive l’autrice – inizia ad avere un posto centrale all’interno di questa raffigurazione del Ventennio nel corso degli anni Cinquanta, in coincidenza del passaggio da un atteggiamento difensivistico nei confronti del passato alla non celata nostalgia di alcune sue parti».
Si può provare, partendo da questo indizio, ad allargare lo sguardo, inseguendo altre tracce dell’eredità coloniale. Le troviamo, prima, nel genere peplum, ossia quel cinema che riprende, nei vari colossal, il mito della Roma imperiale; poi negli spaghetti-western, nel tema della conquista; nei film di Totò, con un umorismo che talvolta richiama l’immaginario sui selvaggi neri, sull’Africa, sulla Somalia. Scopriamo narrazioni a proposito della linea del colore nelle pubblicità che parlano di Mediterraneo – si pensi, per esempio, alle creme solari. Altre, orientaliste, propongono crociere da sogno in Nord Africa e Medio Oriente. Non mancano i reportage sulle guerre di liberazione in Africa e Asia, su popoli considerati non (ancora) bianchi/civili/sviluppati.
Poi ci sono i testi scolastici, alla voce colonialismo; la letteratura e alcuni editoriali giornalistici, come ha fatto notare Valeria Deplano. E la televisione? Un caso su tutti: l’intervista di Bisiach a Montanelli. Il giornalista si vanta di aver comprato una ragazza dodicenne bilena. «In Africa è un’altra cosa», confessa orgoglioso al pubblico. È già il 1969. Non è possibile dunque parlare di rimozione. Gli italiani dimenticarono l’oltremare, ma tennero ben impresse, nelle loro menti, le forme del dominio e gli stereotipi a esse legate. E declinarono questi ultimi su altri corpi, in altri contesti, a partire dal dopoguerra.
C’è poi un’altra questione. Chi avrebbe rimosso l’oltremare? Tutto il Paese? Difficile pensarlo. Forse, allora, solo la parte che aveva conosciuto, direttamente o meno, le colonie. Pur prendendo quest’ultima ipotesi per buona, bisognerebbe capire come avrebbe fatto un gruppo a imporre una rimozione a tutti. Che, ricordiamolo, è cosa ben diversa dal dimenticare, dall’oblio, dall’amnesia. Si rimuove per un trauma subito. Ed eccoci, quindi, alla seconda questione: perché a rimuovere quel passato dovrebbe essere stato un Paese colonizzatore? E non, invece, chi subì le violenze dagli italiani? Questo cambio di prospettiva, tra vittime e carnefici, è inquietante. Chi visse in colonia, probabilmente, non ne parlò per imbarazzo, nostalgia, malinconia, rabbia.
Infine, solo una parte minima del problema riguarda il ritardo della storiografia nello studio del colonialismo. Il centro della discussione va trasferito dallo sviluppo della disciplina storica alla società italiana, alla cultura del Paese. Questo spostamento di sguardo – che poi, come ha insegnato Stuart Hall, lo è anche dal punto di vista dei significati – permette di studiare la memoria pubblica e privata. Anche dietro l’attuale sgombero di piazza Indipendenza: c’è una mancata rielaborazione, una mancata decolonizzazione. La memoria, in tal senso, è intesa come causa. Ma è vero pure il contrario. Può essere medium e archivio nella costruzione degli immaginari del presente, delle memorie del futuro, determinando le condizioni (inter)soggettive che portano alla classificazione del mondo, alla scelta, all’azione.
In tale processo è evidente il ruolo della trasmissione dei significati: idee, immagini e pratiche sono giunte, talvolta modificandosi, fino all’oggi. Sono possibili molteplici processi di memoria, ma non la rimozione che, per caratteristica, prevede la rottura del discorso per un trauma. In una frase: gli italiani hanno dimenticato le colonie, non come si inventa l’Altro. Non a caso, l’immagine del poliziotto che tiene la testa della donna eritrea è stata letta, da alcuni, in modo paternalistico. Questa, sì, potrebbe essere un’eredità diretta della «colonia per maschi» di cui parla Giulietta Stefani nel suo libro.
È qualcosa che urta, se si ricordano le fotografie ingiallite dell’oltremare così ben analizzate da Alessandra Ferrini nel documentario Negotiating Amnesia. E quelle di uomini che posarono davanti alla macchina da presa ghermendo, con le loro mani bianche, corpi neri. Donne metafore della conquista della terra e del paese, di un popolo; donne oggetto di violenza e poi abbandonate. Come nell’operazione di «cleaning» di piazza Indipendenza.
Il discorso vale anche per il manifesto diffuso da Forza Nuova sullo stupro di Rimini; manifesto che ne risignifica uno della Rsi contro lo sbarco degli americani in Italia: cambiano contesto e riferimenti, ma rimangono i contenuti; vale per il titolo di Libero, «Dopo la miseria portano malattie», che se decostruito porta a molteplici narrazioni sulla razza, non solo coloniali. E per le voci contrarie allo ius soli che sono, evidentemente, legate alla mitologia del sangue come costruzione razziale di una nazione, di una patria. La memoria può essere soggetta a molteplici processi.
Certo, la rimozione, ma anche l’amnesia, il ricordo, l’afasia, il silenzio, l’oblio, la risignificazione. Per decolonizzare la memoria non basta, purtroppo, ricostruire gli eventi d’oltremare. È necessario comprendere come funziona l’archivio che ha prodotto tali processi e le narrazioni relative. Ann Laura Stoler mette in guardia, in Duress: Imperial Durabilities in our Times, sull’intendere la relazione coloniale-postoconiale come lineare, diretta, consequenziale. Invita a interpretare i rapporti di potere, passati e presenti, come una mancanza da indagare.
La rimozione, in tal senso, non permetterebbe lo studio sui processi culturali, ma solo degli esiti prodotti. Inoltre, è essenziale decentrare lo sguardo dalla relazione nazione colonizzatrice-colonia, facendo attenzione all’influenza delle discorsività di altri colonialismi, come già chiariva Edward Said; della schiavitù e delle deportazioni; dall’antisemitismo e dalla xenofobia, ecc. Infine, è indispensabile adottare uno sguardo intersezionale, in modo da scorgere le genealogie dei rapporti di potere.
L’invito allora è quello di pensare la memoria non solo come ricordo, ma anche quale strumento per analizzare le varie discorsività visuali, orali, scritte, presenti e passate. Mappare i molteplici processi che interessano la memoria del colonialismo. A sciogliere i nodi di tale eredità come pratica culturale. La decolonizzazione del pensiero, perciò, riguarda tanto il passato, e lo studio storico degli spostamenti di memoria relativi all’oltremare, quanto il presente, ossia l’immaginario xenofobo, islamofobo, razzista e sessita che recupera, in modo incessante, immagini da quell’archivio ancora funzionante per inventare sempre nuovi nemici, interni ed esterni.
Fonte: il Manifesto


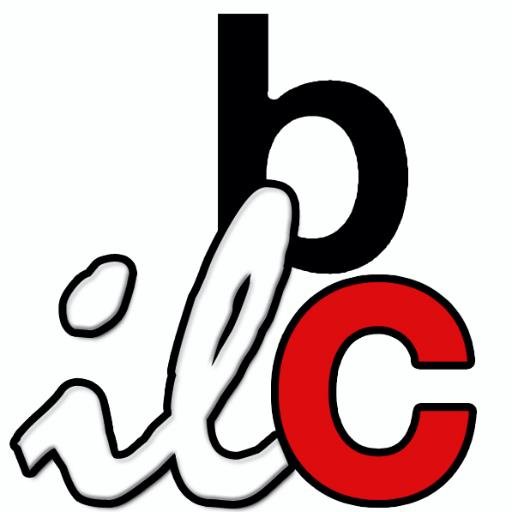









0 Comments