Il calumet tradito: il genocidio dei nativi americani

Lo sterminio degli indiani d’America riletto come frutto di ideologia e bieca incapacità di capire. Lo studio di Peroncini e Colombo
Quattro cannoni revolver Hotchkiss erano stati disposti in due batterie su una bassa collina che dominava l’accampamento dove erano stati sistemati più o meno 350 indiani che, affamati e semicongelati, sotto la guida del vecchio e ammalato capo Big Foot, volevano cercare rifugio nella vicina riserva di Pine Ridge, in Sud Dakota. Erano 120 uomini e 230 fra donne e bambini. La loro colonna procedeva verso sud attraverso la Badlands, uno dei più caratteristici paesaggi western. Intercettata dal Settimo cavalleggeri, ricostruito dopo la sconfitta di Little Bighorn, 14 anni prima, era stata scortata al campo militare di Wounded Knee, un torrente a una trentina di chilometri dalla riserva.
Qui all’alba del giorno dopo, il 29 dicembre 1890, era stato loro imposto di deporre le armi. Gli indiani avevano scelto di farlo, ma bastò un colpo in aria partito per sbaglio dall’unico winchester in loro possesso a scatenare la furia omicida di soldati stressati e ufficiali che per troppo tempo avevano represso il desiderio di vendicare Custer. I fucili automatici contro pochi guerrieri a cui erano rimasti solo alcuni coltelli. Il resto lo fecero gli Hotchkiss. Armi leggere costituite da cinque canne rotanti calibro 47 che sparavano proiettili esplosivi del tipo degli shrapnel che diverranno tristemente famosi nella Grande Guerra. Ma questa non era nemmeno una scaramuccia.
Sulla neve gelata, con Big Foot, restarono quasi duecento indiani. Molti che riuscirono a fuggire morirono di stenti e di freddo in seguito. Una cinquantina, fra cui solo 4 uomini, vennero alla fine condotti a Pine Ridge. Finisce qui la storia del popolo libero dei Pellerossa. Non è però ancora la fine del genocidio. Privati delle loro tradizioni e della caccia al bisonte, molte migliaia moriranno ancora nelle riserve in totale povertà, stremati dall’uso eccessivo di alcol. Anche i pochi gruppi che erano riusciti a rifugiarsi in territori inospitali, decimati dalla fame e dalle malattie, dovettero presto cedere ai bianchi per salvare quel che restava delle loro donne e dei bambini.
In questi ultimi decenni, alla retorica yankee della conquista del West si è affiancata una retorica revisionista, spesso in stile ambientalista e radical chic, sostenuta da tanta cinematografia che ha provato a fare i conti con la storia, ma forse troppo poco ancora con la verità (cioè continuando a seguire cliché occidentali in stile marxista o libertario), attraverso film anche di successo come Un uomo chiamato cavallo o Balla coi lupi, per non dire di Soldato Blu, di Sfida a White Buffalo e di film di animazione come Pocahontas. Troppo poco, però, si è detto sulla verità dell’uomo rosso.
Non la verità sul genocidio, che da decenni ormai più nessuno è in grado di smentire, ma la verità relativa al suo stile di vita, al suo modo di pensare, di costruire famiglia e comunità, alle sue tradizioni viste fuori dal ‘pittoresco folklore’. Per dirlo in una parola, troppo poco si è parlato di civiltà e troppo di uomo selvaggio. Per questo è interessante muoversi nelle pagine di questo libro di Gianfranco Peroncini e Marcella Colombo, due giornalisti e fotografi con la passione per la storia: Al Dio degli inglesi non credere mai. Storia del genocidio degli indiani d’America 1492-1972 (Oaks, pagine 429, euro 28,00).
Un testo che, fin dal titolo, si sforza di leggere dal punto di vista degli indiani le vicende di quello che è stato a tutti gli effetti uno scontro di civiltà, in cui fin dal principio era chiaro chi avrebbe vinto e chi, quindi, avrebbe riscritto la storia con la sua visione del mondo, senza alcuna possibilità di convivenza o integrazione, né fra gli uomini né, tantomeno, fra le culture. Si pensi semplicemente che fra il 1778 e il 1871 nessuno dei circa 400 trattati stipulati con gli indiani è mai stato rispettato dal governo americano sebbene nessuno di essi sia mai stato abrogato dal Congresso.
Ed è curioso constatare che questa idea di superiorità occidentale si sia spinta al punto di condizionare per quasi due secoli anche la lettura della storia dell’uomo in America, partendo dal presupposto che tutti i cosiddetti ‘nativi americani’ dal nord al sud del Continente provenissero da popoli delle steppe russe che avrebbero attraversato lo stretto di Bering fra i diecimila e i dodicimila anni fa. Tutto per sostenere che il loro diritto sul territorio non era vecchio che di sole poche migliaia di anni (quindi suscettibile di cambiamento) e che comunque l’idea di civiltà non era cosa nata in America.
Una convinzione ideologica durata fino a pochi decenni fa, nonostante si moltiplicassero ritrovamenti umani risalenti a 20 mila, 40 mila e forse a 200 mila anni fa. Si era giunti persino a nascondere il curioso fatto che nel 1877 il capo indiano Chief Joseph arrendendosi al generale Miles gli fece dono del pendente della sua collana, che si rivelò essere una tavoletta mesopotamica che registra la vendita di capi di bestiame. Naturalmente anche nel mondo dei pellerossa non era tutto idilliaco, ma era logico che questa visione ideologica e preconcetta dei bianchi finisse per ridurre a sottocultura selvaggia tutto ciò che aveva a che fare con lo stile di vita di queste popolazioni.
Anche gli aspetti poetici di una fede che aveva il suo dio in Wakan Tanka, il Grande Spirito creatore, colui al quale facevano riferimento tutte le cose in un equilibrio di vita e di morte che teneva insieme cielo e terra, in cui alla preghiera dell’uomo, che rivolgeva a lui tutto se stesso, il cielo rispondeva con la fecondità del sole, il ritmo delle stagioni e la ricchezza delle mandrie di bisonti. E preghiera era anche il fumo che saliva dal calumet appositamente fatto di legno, di terra rossa per il fornello e decorato di forme di animali e di penne d’aquila per dire che con quella dell’uomo saliva al cielo la preghiera di tutto il creato.
Fonte: Avvenire


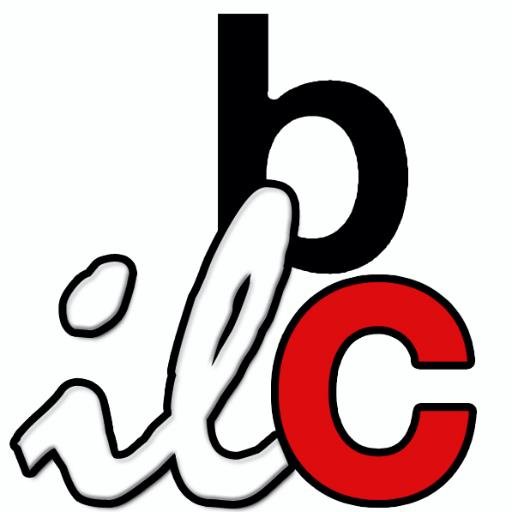






0 Comments