Sulla mia pelle – La recitazione di Alessandro Borghi

di Gianni Canova
Un corpo e un letto. Nient’altro. Un corpo rannicchiato, devastato, tumefatto, profanato. I muri spogli di una cella. Sbarre pesanti, colori lividi. E un corpo: corpo che soffre, corpo che rantola, corpo che muore. Sulla mia pelle – il film di Alessio Cremonini ispirato alla tragica vicenda di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e deceduto in carcere, in circostanze ancora non del tutto chiare, nell’ottobre del 2009 – è prima di tutto questo: un’asciutta e dolente ricognizione sul mistero e lo strazio di un corpo che muore.
Come già Michael Fassbender in Hunger (2008) di Steve McQueen, Alessandro Borghi fa del suo corpo scarnificato e ulcerato lo strumento espressivo attraverso cui il cinema si fa mondo, storia, tragedia, emozione. Un dimagrimento forzato che lo porta a perdere una ventina di chili in poche settimane. Un lavoro mimetico quasi da Actor’s Studio che lo immerge a poco a poco nella postura, nei tic, nella lingua e nelle ossessioni della persona “vera” a cui deve ridare vita. Ma poi, soprattutto, un corpo a corpo con sè stesso per entrare davvero nella testa e nella psiche di un trentenne arrestato dai carabinieri una sera d’autunno e ferocemente stritolato dai gangli kafkiani di un sistema giudiziario attraversato da una vena incomprensibile di violenza sorda e cieca.
Alessandro Borghi cuce Cucchi sulla sua pelle. Se lo tatua addosso. Si taglia i capelli come li portava lui. Fa un lavoro incredibile sulla lingua che a poco a poco si spappola e si spegne: da metà film in poi, sdraiato sulla branda della sua cella, su un tavolaccio o su una barella, rannicchiato in posizione fetale, atterrito da chiunque gli si avvicini, Borghi/Cucchi non parla più: sibila, mugola, biascica, rantola, mormora.
Deriva del linguaggio, naufragio del senso. Solo con un altro detenuto recluso nella cella di fronte Stefano riesce a dialogare. Ma noi questo interlocutore non lo vediamo mai. Forse non esiste. Forse è solo il parto dell’immaginazione di un uomo solo, umiliato, pestato, che non riesce più a muoversi, a pisciare, a parlare, e che sente incredulo e attonito l’appressarsi della morte. Ed è proprio questo che colpisce e graffia e commuove nel film di Cremonini: non la denuncia (che non c’è…), non il calvario (nella storia di Cucchi non c’è alcuna redenzione, nulla di cristologico), non la lotta (Cucchi non è il Bobby Sands di Michael Fassbender che sceglie deliberatamente di morire).
A colpire, e a colpire duro, è piuttosto l’ammutolita messinscena della morte che arriva. La rappresentazione di un corpo che sente, che oscuramente avverte l’avvicinarsi della morte. Immobile, livido, tumefatto, Borghi trasforma la sua faccia in una maschera/smorfia che ricorda certi volti espressionisticamente devastati dell’arte contemporanea: ma più Giacometti che Munch, perché Stefano/Borghi non urla, non protesta. Rifiuta le cure. Sente i suoi occhi incrostati ridursi a fessure. Sente di perdere i contatti col mondo. Sente la vita che va via. E lui non reagisce. Lascia che le cose accadano. Lascia che la morte arrivi, fatale. È questo che sconvolge. Questo che fa di Sulla mia pelle un film che va ben oltre il caso di cronaca che lo ha ispirato: il fatto che racconta e mette in scena un silente e devastante appressamento della morte.
Tutto il resto passa in secondo piano: le polemiche, le discussioni sulla veridicità e attendibilità della ricostruzione, le battaglie sulle modalità di distribuzione del film. Questioni serie, certo. Ma a condizione che non offuschino la cosa più importante: la sobrietà, il rigore, la misura della messinscena di Alessio Cremonini (avete notato la forza del pianosequenza di tre minuti e mezzo nella scena dell’arresto?) e l’intensità commovente dell’interpretazione di Alessandro Borghi. Che ci fa vedere sul suo corpo, come poche altre volte abbiamo visto al cinema, il mistero irresolubile del vivere e del morire.
Fonte: we love cinema
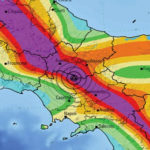

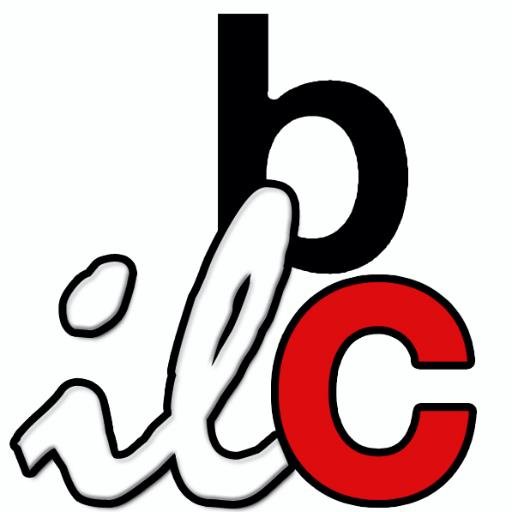




0 Comments