Viaggio nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, Foggia

di Francesco De Lellis (La Città Invisibile, Termoli)
Aboubacar la chiama Messico. Perché è terra di nessuno, dice. Messico non è una città. Ci si arriva solo attraverso strade fangose in mezzo ai campi. La chiamano “la pista”, ma non te ne accorgi subito, lo si capisce dopo quando la attraversi. È vicino a Borgo Mezzanone, ma non è Borgo Mezzanone. Borgo Mezzanone è un paesello di architettura fascista, due bar, una scuola elementare, che non ha quasi nessun legame umano con Messico. Borgo Mezzanone vede Messico da lontano, vede i suoi abitanti arrivare a piedi e prendere l’autobus per Foggia, vede la notte le luci e sente le musiche del campo. La guarda storto ma non ci può fare niente.
Messico è una bolla nel buio. Ci arrivo di notte seguendo le luci e le musiche. Rispetto all’anno scorso dicono che quest’anno ci sono molte meno persone. Comunque tra le casette del vecchio CARA e le baracche saranno 6-700 persone? Chissà. Forse nessuno ha stime precise, e in fondo non è poi così importante. A Messico la notte fa freddo. Nella baracca di Aboubacar che ci ospita non c’è corrente. Quindi niente luce e niente riscaldamento. Lo fa per risparmiare. A Messico non si pagano le bollette, ma un allaccio alla rete costa 70 euro. Un tecnico viene e porta un lungo filo che viaggia sopra le altre baracche e le stradine e arriva fino a casa tua. Spesso però la corrente salta e non si sa quando ritorna. Per chi non ha corrente, d’inverno, già dalle cinque di pomeriggio tutte le operazioni si svolgono all’oscurità, solo con qualche torcia, e ci si inventa qualcosa per scaldarsi. Il giorno prima che arrivassimo una baracca era andata a fuoco alle cinque di mattina, distruggendo tutto, senza che i suoi abitanti potessero recuperare le loro cose, ma per fortuna nessuno s’era fatto male. Il giorno dopo che siamo andati via due uomini sono morti asfissiati dal monossido di carbonio, forse avevano portato un fuoco dentro e si sono addormentati. Chissà se gli avevo stretto la mano, se avevo incrociato il loro sguardo.
Messico è una città crudele, dove non esiste il bene e il male, che se ti fermi a giudicare non assolvi quasi nessuno. Si chiude la porta a chiave quando si esce di casa, perché possono rubarti qualunque cosa. Si chiude a chiave anche quando si dorme, perché non si sa mai. E meno si parla con altri di se stessi, delle proprie ricchezze e delle proprie debolezze, e meglio è. Non ci si può tanto fidare di nessuno. Tutti sono pronti a fregarti. “Make money, not friends” c’è scritto con la bomboletta su una delle casette in cemento del vecchio aeroporto militare, in un decalogo di regole di vita. Aboubacar ha messo sù un suo piccolo commercio vendendo dentro il campo cose di fuori, e così si guadagna da vivere. La mattina quando si sveglia deve fare il giro per riscuotere. Lui piccolo, mingherlino, deve farsi rispettare, pretendere anche il saldo di due euro. Lui col suo occhiale da sole e la camminata da bullo, non ha altre possibilità per campare se non fare il duro. Lui ha detto che per i padroni non ci vuole lavorare più. In campagna ci è andato, poi ha fatto il capo nero, quello che porta i braccianti con la macchina. Ma sta ancora aspettando i soldi dal capo bianco, il caporale bianco che fa da intermediario con il padrone. Così ha deciso di mettersi in proprio, e non può fermarsi perché è diventato un ingranaggio essenziale dell’economia del campo. Lui manda i soldi alla mamma, e preferisce questa vita anche al centro di accoglienza. Perché rimarrebbe incastrato in un posto dove ti dicono quello che devi fare, magari senza poter lavorare e fare soldi. Aboubacar non può perdere tempo con i ritmi dell’accoglienza, dei tribunali, delle questure. Infatti si è dimenticato un appuntamento in commissione per la richiesta d’asilo, e chissà se andrà al prossimo.
Messico è anche un posto di affetti e di addii. Entrando prima di arrivare a casa si fa un primo giro di saluti. Gaia, la mia accompagnatrice si ferma da Moussa, un gigante con il sorriso delicato, che arrostisce ali di pollo su una grata di ferro appoggiata su un grande bidone dentro il quale accende il fuoco (il giorno dopo le ho mangiate, sono tenere e buonissime). Con Moussa viveva Maria, giovanissima dell’est Europa, di cui io sento solo i racconti. Maria se n’è andata qualche mese fa, non s’è capito bene come, all’ospedale di Foggia. Hanno dovuto raccogliere i soldi per far tornare la salma al suo paese. Chissà come c’era finita lì, in un campo abitato quasi solo da uomini africani, dove le uniche altre donne sono quasi solo quelle dei bordelli. La sua assenza la si percepiva molto, dai racconti di chi le era affezionato, dalle foto attaccate sulla baracca di Moussa, che è triste quando gliene parli perché le voleva davvero bene.
Messico è anche un pezzo d’Africa. Un’Africa inusuale però, dove convivono nello stesso posto nigeriani, gambiani, senegalesi, somali, qualche tunisino, pakistani e un po’ di afgani. La mattina comincia a risuonare la musica da qualche baracca, girando per le vie principali è obbligatorio fermarsi a prendere caffè Touba, più d’uno, ogni volta che si incontra qualcuno o come scusa per fare due chiacchiere. Il caffè Touba crea dipendenza, specie se bollente quando hai il corpo freddo dalla notte, sa di pepe e chiodi di garofano. A Messico ci sono alcuni dei ristoranti africani più buoni d’Italia. C’è Amina con la sua piccola cucina, lavora in proprio, oggi non vive più nel campo, e sembra contenta. Arriva alle 7 ogni mattina e comincia a cucinare per il pranzo, e va via la sera dopo cena. Le sue mani affettano, mischiano, puliscono, assaggiano con gesti collaudati ed eleganti. La gente ci guarda in modo strano quando ci vede lavorare insieme a lei. Due bianchi in cucina, a lavare pentole e tagliare carote? Amina dev’essere proprio diventata ricca! Penseranno. A Messico quando non si lavora il tempo si può passare in compagnia, facendo un giro e chiacchierando. A Messico, che è un po’ Africa, riscopro che il tempo non deve per forza essere occupato dalle cose da fare, che gli incontri non sono un altro impegno in un’agenda di impegni, che si può andare a bussare a casa di amici e stringersi in una stanzetta minuscola a chiacchierare, si può giocare e chiacchierare al buio.
Messico è un luogo di fantasmi. Qui si arriva magari per lavorare una stagione in campagna ma poi ci si resta. Per chi è senza documenti è un nascondiglio ideale, terra di nessuno dove non entra nemmeno la polizia, se non quando muore qualcuno o quando arrivano le ruspe a buttare giù un po’ di baracche. Qui si concentrano gli invisibili sputati fuori dal sistema dei permessi e dell’accoglienza, quelli che non hanno più nessuna possibilità di stare legalmente in Italia. Meno se ne parla fuori e meglio è, perché la condizione essenziale per poter restare qui e sopravvivere è che Messico resti un buco nero, un non detto per il resto del mondo. Per noi, che vorremmo denunciare e raccontare, è una contraddizione che non riusciamo a risolvere. Se prima era una baraccopoli temporanea legata soprattutto alle stagioni di raccolta degli ortaggi, oggi ormai è un luogo di permanenza stabile da cui in tanti se ne vorrebbero andare ma non possono, perché fuori da lì non sono nessuno, rischiano la detenzione amministrativa in un cpr o il carcere o l’espulsione, o comunque il marciapiede di qualche città. Così Messico ha cambiato faccia, alcune baracche, dopo gli incendi, stanno diventando vere e proprie case in mattoni bianchi. E vive ormai di vita propria.
Messico non può vivere senza Foggia. E Foggia, e l’Italia, non possono vivere senza Messico. Ma i due mondi si toccano poco, spesso solo per scambiare merce. I bianchi che entrano vengono a cercare droga, sesso, a vendere o a comprare oggetti o manodopera. Gli uomini che vanno ogni mattina a lavorare nei campi, o le donne che vanno nelle fabbriche dell’agroalimentare che confeziona gli ortaggi, per 4 euro e 50 all’ora, senza contratto. Gli altri bianchi che ci mettono piede, alcuni giorni a settimana sono quelli delle organizzazioni umanitarie. Si prova a rendere più vivibile una vita disumana. C’è il campo di lavoro estivo Io ci sto, promosso dai missionari scalabriniani, che a creare un ponte tra il ghetto e la comunità locale ci prova ogni anno con volontari da ogni parte d’Italia. Poi c’è la radio, Radio Ghetto, un collettivo che non fa lavoro umanitario, semplicemente apre un microfono, prova a dare parola e a raccogliere le voci delle persone. È complicatissimo immaginare e stimolare uno sforzo di emancipazione collettiva, ognuno è troppo impegnato a salvare se stesso per farsi carico di altri. Due bandiere di sindacati le ho viste sgualcite su qualche baracca, e un grosso striscione di plastica è diventato rivestimento esterno per una casa (ottimo per il vento e l’umidità).
Messico è una baraccopoli, uno slum, un ghetto, una bidonville. Come quelle che una volta leggevamo nei libri sull’India o nei racconti dalle metropoli africane. È un posto che nasce dallo sgombero di un altro accampamento informale, e si stabilisce accanto a un centro di accoglienza, che ormai è anche quello occupato da persone che non hanno un altro posto dove andare. Sta lì da quattro anni. C’è chi ormai ci è stanziale, chi ci passa periodi più o meno lunghi quando perde il lavoro o quando torna in Italia per rinnovare il documento. C’è chi fa il pendolare e lavora per metà settimana nell’accattonaggio a Termoli, e l’altra metà la passa qui. È un posto dove la vita costa poco ma costa, si paga l’affitto della baracca, si paga il sesso, si paga 2 euro per un pasto caldo, si paga il pane, si pagano le stufe. I negozi vendono di tutto. L’Afghan shop è chiamato il “mercato bianco”, forse perché i gestori sono afgani e quindi bianchi, oppure perché è una costruzione di mattoni e cemento pulita e rifinita, non l’ho capito. Ci sono i barbieri e le parrucchiere, il gommista e il meccanico, il sarto, il macellaio che sgozza e squarta le pecore, ci sono i ristorantini e i bar, che sono anche case di piacere. Ci sono i cani scalcagnati che dormono sui materassi abbandonati e ballano, nell’immondizia che non raccoglie nessuno, e che ogni tanto brucia quando è troppa. Ci sono le chiese, c’è una grande chiesa nigeriana, una struttura grande in cemento. Ci sono le moschee, e durante uno sgombero la gente si è ribellata quando le ruspe volevano buttarne giù una, hanno lasciato che abbattessero le case, ma hanno difeso un luogo di comunità, e sono riusciti a salvarla.
Messico vive precaria come ogni altra area informale del mondo, e magari sì, un giorno verrà sgomberata, ma rinascerà da un’altra parte e magari un giorno un’amministrazione ci porterà anche le fogne e l’acqua. Forse bisogna smettere ormai di pensarla come una bolla fuori dal tempo, perché è parte del nostro tempo, è un pezzo della nostra civiltà, che non può più girarsi dall’altra parte e pensare che queste sono cose da terzo mondo, che qui non succede. Messico la leggeremo nei giornali quando ci saranno i prossimi morti, quando cercheranno i colpevoli di qualche omicidio, quando magari esploderà una rivolta violenta. Ma ci conviene ancora pensarla con distacco, dall’alto del nostro privilegio, o dal basso del nostro disagio, come qualcosa di altro e distante. Quel confine però non esiste più, in Italia esistono le baraccopoli.
Ci mancano, ci servono, strumenti per capire e per agire. Siamo venuti senza un compito, una missione. È difficile trovarne una, o se ne potrebbero trovare molte, ma non avrebbe senso pensare di arrivare qui e salvare qualcuno. Neppure però si deve correre il rischio di diventare turisti in visita a un’umanità esotica. Gaia mi dice che in fondo ci si viene e ci si torna per trovare amici, mangiare cose buone, incontrare gente nuova. Ce ne sarebbe di lavoro politico e sociale da fare, e sicuramente va fatto. Ma da dove cominciare? Se mai si farà non potrà che partire dalle relazioni e dal tempo passato insieme. Quel tempo a cui spesso magari non diamo valore se non è speso a fare qualcosa di utile.


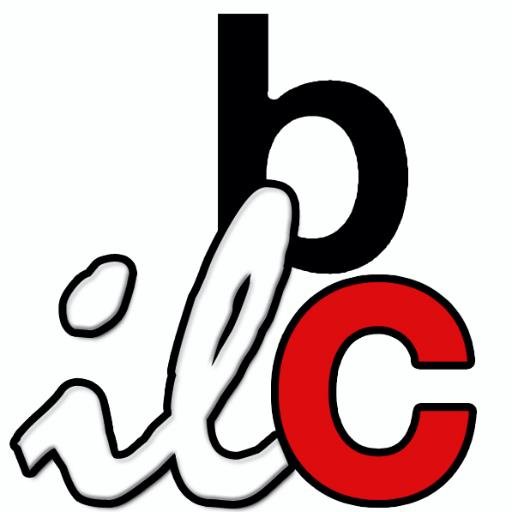









0 Comments