#LACULTURANONSIFERMA. Quarantena di parole. Note dal taccuino nero di Letizia Bindi

di Letizia Bindi
Il primo decreto mi ha colto in Molise, facendo sì che per ragioni complesse vi rimanessi, nonostante il blocco delle attività in presenza e la possibilità di rientrare alla mia residenza. Così, nella mia dislocazione strutturale, tra i tre poli di vita rappresentati dal Molise, la Toscana e la Lombardia, il tempo della mobilità forsennata si è bruscamente arrestato, congelando i diversi pezzi della mia famiglia in luoghi diversi e consegnandoci un tempo di lavoro a distanza e affetti in videochiamata. La campagna dove mi trovo a vivere è quella di un territorio che conosco bene, un mio ‘campo etnografico’, divenuto col tempo un luogo di vita, di amicizie e famiglia.
Per diverso tempo il virus è rimasto sullo sfondo, per certi versi lontano, nonostante qualche allarme, dal contagio più prossimo. Solo, di tanto in tanto, il timore di qualche quarantena. Eppure questo osservatorio appartato mi pare fornire qualche spunto per una osservazione dell’epidemia da un’area per certi versi periferica, riposta, lontana rispetto alle grandi mobilità e ai poli più a rischio, con le sue dinamiche difensive e simboliche.
Come in tutto il Paese, il tappeto informativo è stato e resta imperversante, ad alimentare quel contagio secondo cui “le informazioni ed emozioni si trasmettono da una persona all’altra come si trattasse di un virus”, rilevate e analizzate nelle loro interne dinamiche dagli studiosi della Scuola di Chicago e dai teorici della folla e del condizionamento delle masse (Park-Burgess 1921, ad esempio.) Tuttavia, ciò che qui colpisce è un diffondersi accanto alla comune paura del contagio di un timore del controllo, una osservanza impaurita delle regole sulla mobilità che sembra più dettata dal rischio delle sanzioni che da quello della malattia (Cohen 1971). Si diffondono racconti elaborati, storie esemplari, ribattute in infinite conversazioni telefoniche su persone bloccate sulla via dell’orto o denunciate per aver cercato di andare a prendere il pane per la madre.
Un tema frequente è legato alla privacy circa i casi di contagio, rispetto ai quali si scatenano polemiche, perché qualcuno avrebbe fatto i nomi dei contagiati, come se fosse un marchio e non una pratica utile al contrasto dell’epidemia. Si riattiva rispetto al virus quello stigma verso l’untore che prescinde dalla natura della malattia e dalle forme del suo passaggio, ma anche quell’omertà rispetto alla morsa del controllo sociale che fu già oggetto della riflessione degli studiosi degli anni Cinquanta che notavano come vi fosse nelle società contadine “una sfiducia quasi patologica nell’«altro mondo» (quello del governo e della nobiltà paesana che, essi credono, cerca continuamente di ingannarli)” (Friedmann 1952).
Un senso diffuso del controllo e della repressione si affaccia, memoria relativamente recente di una condizione subalterna e piena di paura, per molti. Rispetto al rischio di essere bloccati dalle forze di polizia, prevale una rappresentazione sconveniente, criminalizzata. Un’evenienza da evitare con ogni cura, come fosse cosa prossima all’incorrere in comportamenti criminali gravi. Si racconta, ad esempio, che tizio o caio hanno incontrato una pattuglia che ha loro chiesto generalità e motivi dello spostamento.
Lo si fa abbassando un poco la voce, come quando nei paesi si narra qualcosa di sapido e sconveniente a carico di una persona. Prevale l’idea che non lo si debba dire, come una vergogna e di fronte a ognuno di questi avvenimenti si rafforza l’idea di dover rimanere a casa per non incorrere in sanzioni.
Si infittiscono le comunicazioni telefoniche, un continuo circuito di chiamate di rassicurazione sullo stato di salute specie all’indirizzo dei parenti trasferiti nel Nord Italia o all’estero. Rispetto a questi prevale preoccupazione e compassione, a rafforzare il senso già persistente di un doloroso e inesorabile destino migrante, di che ha dovuto rinunciare alla vicinanza della famiglia e alla propria terra “pe fatjà”. Le relazioni si strutturano in quell’intreccio emozionale e di negoziazioni tra aspettative e negazioni, tipico delle famiglie dislocate a causa delle diaspore (Baldassar 2007, 2014).
La consistenza dell’epidemia appare vaga: le notizie, che pure si ascoltano con una certa attenzione, sembrano non essere comprese a fondo. Soprattutto circa le modalità del contagio non c’è chiarezza, tendendo a pensare a una diffusione aerea del virus e non da prossimità e contatto con superfici, allargando con ciò enormemente l’area della paura e del sospetto.
Anche il rapporto ai cibi è soggetto a modifiche. In alcuni di coloro che vivono in campagna cresce la diffidenza verso i prodotti esterni, che già è piuttosto alta in genere, una ricerca se possibile ancora maggiore di autonomia alimentare come a difendersi dal contagio attraverso la non ingestione o contatto con nulla che sia stato prodotto fuori.
Le categorie di contaminato e incontaminato si ispessiscono e complessificano. Cresce il senso di un bisogno di “immunità” che è in primo luogo condizione separata, possibilità di non mescolarsi e di poter stare a casa in sicurezza. Una condizione immune che se è per altri forma del privilegio – come Roberto Esposito ci ha ben mostrato (Esposito 2002) -, nelle aree rurali e periferiche sembra tingersi di una volontà esplicita di evitazione.
Si riconferma, nei minuti gesti di ogni giorno, una volontà di protezione del proprio, del sé – contenuto e delimitato corporalmente dal nostro limite, dalla pelle, dalle mucose da proteggere, una sindrome della protezione dei confini del nostro corpo (Canetti 1992) che è metafora della nostra identità personale e traslatamente dell’intero gruppo cui si appartiene (famiglia, località, ceto). Una “regola della purezza” (Douglas 1966, 1970) che non a caso tiene insieme controllo fisico e sociale insieme con un complesso reticolato di evitazioni e continenze che dovrebbero preservarci fisicamente, così come distanziarci socialmente.
Rispetto al fluire delle informazioni si alterna la compulsiva lettura e ascolto di notizie (tra tv e il chiacchiericcio dei social) e un certo rifiuto, ciò per evitare di riceverne messaggi troppo inquietanti e che sembra quasi non si sappiano gestire.
Diffusamente si affaccia un timore dell’incontro, la condanna di comportamenti troppo sociali, un continuo raccomandare di stare a casa e di evitare ogni forma di contatto. Ogni forma di socialità innovata e di riorganizzazione delle relazioni conseguente all’isolamento viene bollata come frivola o destituita di senso, come nel caso delle chiacchiere di vicinato o dei flashmob o ancora i meeting virtuali che vengono giudicate come leggere e un po’ superficiali.
C’è compassione verso i lutti e la solitudine dei malati deceduti senza l’affetto dei loro cari, ma prevale anche una distanza che implode non appena il racconto o le notizie provengono da qualche parente lontano, portando la crisi della presenza e l’angoscia irrelata della perdita nella sfera stessa del familiare (De Martino 1958). Grande è la preoccupazione verso i propri anziani e la responsabilità estrema del garantire loro cure e immunità. In ragione di questo l’osservanza delle regole di esclusione è molto ligia, intrecciata com’è anche a un timore costante delle sanzioni e dell’incontro con le forze dell’ordine impegnate nei blocchi.
In molti prevalgono preoccupazioni per il raccolto, essendosi cumulate queste settimane con una prolungata siccità. Si vive questo aspetto e l’impossibilità di collaborare con persone esterne al nucleo familiare in campagna come una grave conseguenza del virus e con la percezione acuta del rischio di una cattiva annata.
In molti hanno visto nella prima sospensione sopraggiunta, quella delle celebrazioni di San Giuseppe, momento alto in molte di queste comunità di incontro e socialità, è come segno di un tempo irrimediabilmente cambiato. “È la fine du munn’”, ho sentito esclamare a più di una persona e subito dopo: “vedrai, quest’anno non esce neanche il Santo”. Nell’intimo delle famiglie si sono conservate alcune pratiche – pasta con la mollica e zeppole di San Giuseppe, osservanza del venerdì di magro per la Quaresima. Ci si telefona, per ricordarsi della festa. Qualcuno porta le zeppole ai genitori anziani, le consegna a distanza, perché lavora fuori e “non vuole rischiare”.
Così si mangiano le zeppole da soli e la mollica farcita è sempre troppa, pensata com’era per i pasti familiari e sociali di ‘prima’. Altri insistono sull’anno bisestile come ‘annus terribilis’ e sfortunato.
Eppure più forte ancora è la preoccupazione circa il rischio di una sanità già fragile e smantellata da progressive e recenti chiusure dei presidi ospedalieri: dal racconto di medici distratti alla preoccupazione per un sistema impreparato all’ordinario prima ancora che all’emergenza.
Dalle periferie di una sanità eccellente, dove lo smantellamento del sistema ospedaliero e della sanità pubblica ha toccato livelli profondi di destrutturazione (chiusura di ospedali, sanità commissariata, ritardi colpevoli nell’acquisto anche dei minimi presidi), la percezione unica e sola è che se dovesse arrivare il contagio con prepotenza, qui si sarebbe spacciati. Consapevolezza acuta di una fragilità e distanza che è in primo luogo negazione di piena cittadinanza, marginalità politica e invito implicito, ma neanche tanto, ad abbandonare.
In molti in queste settimane stanno iniziando a riflettere sull’effetto rivelatore che questa epidemia porta al cuore stesso del sistema neo-liberista, al suo nient’affatto sottile baratto tra massimizzazione dei profitti e rinuncia alla salute che oggi ci si ritorce pericolosamente contro. Ma dai margini dei sistemi economici e con essi anche sanitari, dalle periferie dei “biopoteri” questa percezione diventa una sorta di mesto lamento, una rassegnata presa di coscienza del fallimento “del contratto implicito tra gli Stati moderni e cittadini” che consisterebbe nel “garantire la sicurezza e la salute fisica” o per lo meno adeguata assistenza sanitaria (Illouz 2020).
Sale, così, l’insofferenza verso la politica locale tra disillusione e convinzione di insufficienza delle decisioni e azioni intraprese. Eppure, impotente, cresce una sensazione di isolamento e abbandono che è già presente diffusamente nei discorsi e nei sentimenti quotidiani delle persone: senso di essere dimenticati, tralasciati, irrilevanti. “Ch’emm a fá, chess’è”, come in un trito ritornello.
Non ho alcuna pretesa, né intenzione di dire cose definitive su ciò che sta accadendo, rispetto a cui sento, forte, la necessità di riflettere, annotare, studiare. È difficile, infatti, farsi un’idea in queste poche, concitate, seppur immobili settimane, circa le misure adottate – simboliche, pratiche – dalle comunità e dagli individui per gestire e maneggiare la paura e lo straniamento, il contenimento forzato e la percezione di una necessaria rinuncia alle nostre libertà in cambio della nostra incolumità.
Dal campo che implicitamente mi trovo ad osservare non mi pare emergere con la forza, a tratti retorica, evocata dai media, un particolare afflato collettivo, uno speciale senso di comunità e di solidarietà. ‘The places left behind’ (Wuthnow 2018) sembrano sentire acutamente la precarietà e il pericolo che potrebbero derivare dalla pandemia. Consapevoli di un destino minore, di una maggiore fragilità dell’assistenza e del sistema dei servizi sembrano sfiduciati sulle possibilità di tenuta nel caso il contagio dovesse loro avvicinarsi maggiormente.
Al contempo incorporano la regola, la rielaborano nelle forme di un potere lontano e vessatorio che segna con le sue pratiche di contenimento i tracciati dei corpi, contenendone le esigenze e i desideri. Allontana i nipoti e i figli dagli anziani, consegnandoli a una cura di sostentamento, in molti casi, fatta di distanze regolamentari e di spese lasciate sulla porta. Toglie la certezza di certi momenti corali di ritrovo: le feste comandate in cui i giovani trasferiti altrove tornano, in cui si è di nuovo in molti intorno alla tavola, che oggi resta vuota.
Allontana i vivi dai loro morti, toglie – lo hanno rilevato in molti – la pietas del cordoglio a società che ne hanno fatto il loro modo di non passare con ciò che passa, di non essere travolti e inghiottiti dalla negazione della morte (De Martino 1958). Nell’incertezza e nella paura che attraversa questi giorni, sembra ravvivare sistemi di credenza e di pregiudizio verso i potenziali portatori di contagio, di paura del controllo da parte dell’ordine costituito. La ferita portata al cuore delle comunità delle aree interne, la paura e il disagio, il senso di abbandono, ha scavato in molti un senso di rinuncia e di impotenza. Questo non apre il cuore, al contrario fa temere ancora di più che il poco che resta ne risulti minacciato. Serra le porte.


Nel contempo dai territori e dalle comunità con cui lavoro mi giungono ogni giorno telefonate, post, messaggi privati. Con alcuni di loro ho parlato a lungo. Con i pastori, ad esempio, che mi hanno raccontato una loro speciale insofferenza verso l’epidemia: la ridotta mobilità, il crollo del mercato delle carni (c’era la Pasqua alle porte, che ci piaccia o meno), la riduzione drastica degli acquisti caseari in azienda.
Solo chi si era già organizzato da tempo con i gruppi di acquisto e la distribuzione di piccolo e medio calibro sta conoscendo un momento di relativa crescita o stabilità delle vendite. Quelli che si erano anche organizzati e ripensati come agriturismi assistono impotenti, come tutto il comparto turistico, a una crisi drammatica di presenze, alla cancellazione delle prenotazioni per la stagione alle porte.
Alcuni artigiani, connessi alle attività pastorali, così come alcune aziende agricole, abituate a una discreta vivacità del mercato urbano circostante grazie alla vendita dei loro prodotti biologici e di qualità, mi raccontano la diminuzione degli acquisti a distanza e, ovviamente, l’isolamento totale di queste settimane. Non è detto che questa epidemia porti automaticamente a una nuova consapevolezza in tema di produzioni a filiera corta e a basso impatto ambientale.
Ho ascoltato molte conversazioni nei supermercati di paese che inneggiavano ai maggiori controlli della grande distribuzione come una garanzia di maggiore ‘pulizia’ dei generi alimentari.
E poi c’è la paura di non poter celebrare le feste: la chiamerei – parafrasando Erri De Luca – “il giorno prima della fine della fine della felicità” (De Luca 2017). Una paura che in molti casi si è già trasformata in certezza.
Il virus ha spazzato via le calche che in tante occorrenze cerimoniali sono al cuore stesso di quel sentirsi uniti, accalorati ed entusiasti accanto agli altri devoti e partecipanti, quella ostentazione di saper fare e senso della fede che è al cuore stesso di tante pratiche rituali. Ho parlato con gli uomini che corrono sui carri, presi come sono già a difendersi dagli attacchi animalisti e dai problemi inerenti la sicurezza negli eventi pubblici, che oggi più che mai patiscono il blocco imposto dall’epidemia alle loro celebrazioni.
Ho parlato con le famiglie che camminano in processione con i loro carri infiorati per le feste di maggio che hanno sospeso dolorosamente la preparazione dei fiori e l’allegra pratica della doma nelle strade di campagna.

Ci siamo confrontati con i colleghi con cui collaboro a progetti comuni: i colleghi sudamericani, con i quali eravamo insieme pochi mesi orsono. Quelli delle fattorie sostenibili e inclusive delle aree amazzoniche e delle terre alte, preoccupati che il virus interrompa i progetti appena avviati dalle loro comunità rurali; quelli delle comunità pastorali della Patagonia che temono più la miseria e l’esproprio giornaliero di terre e risorse da parte delle grandi multinazionali delle carni e della lana che la pandemia virale. Mi chiamano dall’Albania i colleghi e i pastori del Kelmend che sperano strenuamente nelle prospettive della transumanza, nel freddo tardivo di aprile e nella più dura povertà. Non ignari del coronavirus, ma come intirizziti da un altro freddo, quello della marginalità economica e sociale delle aree montuose dell’Europa orientale.

Mi chiama e mi scrive, quasi ogni mattina Edoardo, dal Venezuela, che non ho mai visto e dovevo incontrare a maggio prossimo sulla strada di Sanare, nello Stato di Lara, per percorrere insieme con i buoi aggiogati e infiorati la via processionale di San Isidro Labrador, il santo contadino. Mi dice che inizia a temere, che nel pueblo i contagi sono 77 e i postivi 15 e non sanno che potrà succedere se dovessero aumentare, che la crisi ha messo fuori uso i già lontanissimi ospedali e hanno paura. Poi mi dice che spera che San Isidro ci protegga insieme con “los ancestros guardianes de la tradición” (Pollak – Elz 1994; Vargas 1987) e che io possa essere con loro a festeggiare quest’anno, che ha tante cose e persone importanti da mostrarmi e farmi incontrare.



Alcuni mi chiedono quasi per scaramanzia se penso che avremo o meno superato la crisi per questa o quest’altra data. Molti già sanno che non sarà così.
Io non so rispondere e con loro, nell’imbarazzo storto della mia laicità piena di rispetto per le devozioni, mi convinco di quanto quelle pratiche siano cruciali per loro e per me e come tutti noi, anche chi ne vive lontano, senza saperne o quasi, beneficiamo di quelle pratiche, seppur indirettamente.
Archivi di memoria e di senso, varianti del vivere insieme, cangiante repertorio del mondo. Forse, se non veniamo travolti dalla disperazione e dal senso di abbandono, è anche perché c’è questo fondo generativo di speranza e di aspettative che giace ai piedi di ogni assembramento che non sia pura casualità, ma abbia deciso di organizzarsi intorno a un racconto fondativo o a una pratica condivisa.
E ogni giorno, tristemente, ricevo sconsolati messaggi che le occasioni festive sono state annullate, a colpi di decreti e di delibere. “Frasi d’amore scritte a macchina” – scriveva anni fa Paolo Conte, per raccontare la freddezza del linguaggio istituzionale applicato a ciò per cui si ha e si è avuto cura e affetto.
Infine penso a ciò che questo tempo mi insegna etnograficamente: alla pausa che mi concede da un compulsivo viaggiare, al tempo che mi da per scrivere note e riflessioni che si sovrappongono al cadenzario usato di consegne accademiche ed editoriali, solo parzialmente modificate dal tempo del “lavoro a distanza”. Nel distanziamento sociale e nella sua ricezione c’è una sfida cruciale per l’etnografia che va ben oltre la dicotomia generativa degli sguardi “da lontano” e “da vicino”. Sfida il cuore stesso dell’incontro etnografico, rendendo ancor più radicale la riflessione metodologica.
Al tempo stesso rifletto sull’insofferenza che provo per tutti gli scritti che parlano di questo tempo come opportunità. Non riesco a pensare al lutto e la morte come occasione per riflettere. Non voglio averne bisogno. Questo tempo non mi piace e non mi appartiene. Sono calma eppure riottosa. Infastidita dal quasi sottile compiacimento che in molti percepisco per l’obbedienza e la conformità alle regole. Resto a casa per responsabilità, ma non ci trovo niente di speciale.
Preferisco il tempo della strada e del camminare con gli altri spalla a spalla, fianco a fianco. Il tempo delle mescole e degli assembramenti. Non saprei dire se, come da molte parti ci viene detto e ripetuto, questa pandemia ci lascerà migliori. Al contrario penso che questo continuo riferirsi al cambiamento radicale che essa porterà nelle nostre vite, al senso nuovo di comunità che dovrà veicolare, sia una nuova grande narrazione, una retorica.
Di cambiamenti ve ne saranno, certo. Si è modificata e si cristallizzerà una disponibilità al controllo barattata con una presunzione di maggiore sicurezza che in realtà già serpeggiava in precedenza. Al di là delle promesse, dei ”nessuno resterà escluso” si amplieranno i divari economici e sociali tra lavoratori strutturati e lavoratori precari, tra piccolo commercio fragile e aziende capaci di reggere e riconvertirsi.
Non so se cambierà e si farà più inclusivo il nostro sguardo verso il mondo, se davvero vedremo crescere, così come si dice, il “senso di comunità”. Nei paesi, nelle piazze del parlottio leggero, ora vuote e private dello scambio minuto di informazioni e pettegolezzi, ma anche di quel mutuo rincorrersi di rassegnata condivisione delle fatiche e dei dolori sembrano crescere sospetto e difesa, distanza e silenzi.

Nel sommesso scrivere di un pomeriggio di quarantena mi giunge un messaggio da Amatrice, terra sofferente e densa, campo etnografico solo apparentemente sospeso in queste settimane. So quanto il senso di perdita e la sofferenza per ciò che sta accadendo, per l’impermanenza che ci indica possa amplificarsi in una terra in cui i crateri hanno inghiottito le vite e gli affetti, il rapporto al passato e persino la fiducia nel futuro. Tra un messaggio e una voce, tra una registrazione e una fotografia mi inviano i versi severi di Antonio Cannavicci, poeta pastore di Campotosto. Quattro versi in cammino, asciutti e fulminanti.
Nén ci circà.
Nèn ci circà: ci séme fatti véntu,
séme gliu fiatu ca manté la fiara;
ci séme fatti acqua de pianàra,
séme le scuru digliu firmaméntu.
Nelle strade senza più pastori né animali, dove oggi non camminano e non corrono i santi, dove non si festeggia la renovatio annuale della festa non so se troveremo più paese, non so se saremo meno soli, quando, come nell’adagio formulare che chiude questa favola nera, “tutto questo sarà passato”.

Bibliografia
Baldassar, L. – Merla L. (eds). 2014. Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life. London: Routledge.
Baldassar, L. 2007. “Transnational Families and the Provision of Moral and Emotional Support: The Relationship between Truth and Distance.” Identities 14(4): 385–409.
Canetti, E. 1992 [1960]. Massa e potere. Milano, Adelphi.
Cohen S. 1985 [1971]. Visions of Social Control. Cambridge: Polity Press.
De Martino E. 1975 [1958]. Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre al pianto di Maria, Torino: Boringhieri.
Esposito, R. 2002. Immunitas. Torino: Einaudi.
Illouz E. 2020. Storie virali. L’insostenibile leggerezza del capitalismo per la nostra salute in “Atlante Treccani”. Fonte Internet: http://www.treccani.it
Park R.E. – Burgess E.W. 1969 [1921]. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The University of Chicago Press.
Pollak-Eltz, A. 1994. La Religiosidad Popular en Venezuela. Un estudio fenomenológico de la Religiosidad en Venezuela. Caracas-Venezuela. San Pablo.
Vargas, C. 1987. Estudio Etnográfico del Comportamiento Mágico Religioso en la Venezuela Contemporánea. Maracaibo-Venezuela: Ediciones Astro Data S. A.
Wuthnow R. 2018. The Left Behind: Decline and Rage in rural America. Princeton: Princeton University Press.


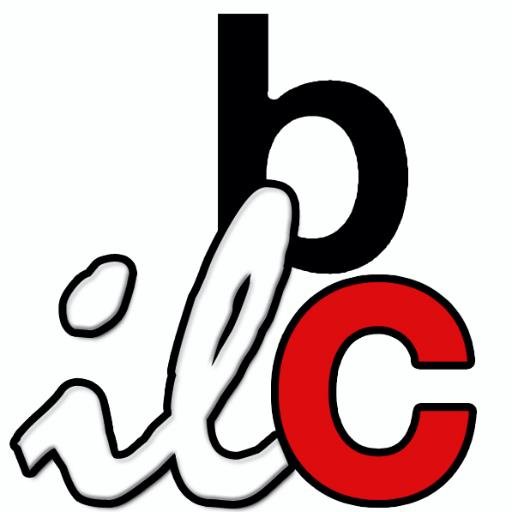









0 Comments