Antonio Di Pietro: «Craxi era solo uno dei tanti. Io puntavo ad Andreotti, mi hanno fermato»

di Susanna Turco
L’ex pm riscrive la storia di Mani Pulite: «L’inchiesta nasce a Palermo, con Falcone e Borsellino, ucciso per quel che poteva ancora scoprire». E poi: «Gardini doveva farmi il nome di Salvo Lima, avrei chiuso il cerchio e aperto il processo mafia-appalti». Sul segretario Psi: «Un politico normale, ha agito come gli altri. Non fatelo più grosso di quel che è»
«Craxi? Ma Craxi era solo uno dei tanti». D’improvviso, allo scoccare della seconda ora e mezza di conversazione, con quel suo modo un po’ buffo e stratificato di parlare – sopra approssimativo, sotto preciso, fulmineo – Antonio di Pietro, 69 anni, ex pm, ex politico, oggi avvocato sostanzialmente lontano dalle scene, butta già l’ultimo feticcio che era rimasto in piedi di una pagina che ripercorre in un modo mai visto. Ci si doveva vedere a pranzo, a casa sua, a Montenero di Bisaccia, per parlare appunto di Bettino Craxi, a vent’anni dalla morte. Arrivati al caffè, quel nome ancora non l’ha pronunciato.
Si muove da tutta un’altra parte. Racconta una storia diversa, un binario parallelo e inedito, che in parte ha depositato nella sua ultima testimonianza, al processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia a Palermo, a ottobre. «Mani pulite è una storia che andrebbe riscritta», dice adesso il volto più noto dell’inchiesta del Pool di Milano che ha buttato giù la Prima repubblica. Lui che è una pagina di storia. E che, quindici anni dopo, si è ritrovato di nuovo al centro dei giochi, nel cuore di uno degli prodotti di Mani pulite, l’onda antipolitica che ha portato – anche all’ombra di Casaleggio – alla nascita e alla crescita dei movimenti tra rete e realtà: non solo il Movimento 5 stelle, ma anche l’Italia dei valori, di cui proprio Casaleggio curò la comunicazione. Ecco lui, uomo di tanti snodi chiamato a parlare di Craxi, quando apre la porta di casa per prima cosa parla del codice penale. Ti accoglie così: «Scusi, ma il 323, io l’ho mai contestato? Non mi ricordo di averlo fatto».
Prego? Il 323?
«L’abuso d’ufficio adesso va molto di moda. Io l’ho sempre considerato una sconfitta dello Stato. Perché vuol dire che non hai la forza di scavare un po’ meglio. Lo dico perché, a differenza di Piercamillo Davigo, che è sempre stato monolitico sul tema – per lui sei colpevole fino a prova contraria – io ormai… Prendete il Codice: al primo capitolo ci sono i soggetti processuali. Ecco, io ho fatto il poliziotto, il giudice, il pm, il testimone, la parte lesa, la parte civile, l’indagato, l’imputato: mi manca soltanto il “responsabile civile per le ammende” e le ho fatte tutte. Ho messo talmente tanti abiti, ho visto così tante giustizie, che le certezze granitiche di Davigo non ce le ho più, perché dipende dai vestiti che indossi, prima cosa. Secondo: sono sempre convinto che noi del pool di Milano abbiamo creato un effetto positivo, ma anche una conseguenza non voluta: pur nell’entusiasmo generale abbiamo creato tanti dipietrini. Già all’epoca: è stato quello che ha bloccato Mani pulite».
A bloccare Mani pulite sono stati i magistrati?
«Mani pulite non è stata fermata dalla politica: è stata fermata dai giudici. È una storia che va riscritta, prima o poi. La politica non la poteva fermare, se i giudici avessero fatto il loro dovere. Mani pulite si ferma oggettivamente quando si rompe l’unicità dell’inchiesta. La sua forza era infatti nel cosiddetto fascicolo virtuale, nell’idea cioè di creare una connessione probatoria tra tutti i fatti, per cui procedeva una sola autorità giudiziaria. Ma nel momento in cui nascono i conflitti di competenza territoriale, il fascicolo si smembra: e allora non ha più tutti gli elementi, non si può più utilizzare, e soprattutto il pm che sta qua, non conosce l’insieme degli elementi del pm che sta là. E allora, nel 1994, ecco gli emulatori: Roma, Napoli, Catania, Foggia, Bari, Venezia, Genova etc. Oltretutto, invece che cercare il reato, ci si è messi a investigare per cercare se c’era un reato… Questo è un lato della faccenda: l’altro sta in quello che è successo a me con la vicenda Filippo Salamone, il dossier Achille, di cui ho parlato nell’aula bunker».
A Palermo ha detto anche che Mani pulite si interrompe quando arriva alla connessione appalti-mafia. Partiamo da qui?
«Parliamoci chiaro. Ho intenzione prima o poi di parlarne, sto portando le mie carte e i miei documenti un po’ qua e un po’ là, nell’indecisione di cosa farci: io e mia figlia li vogliamo bruciare, mio figlio e mia moglie dicono di no. Ma se adesso si pensa di intitolare una strada a una persona esiliata, e si dice che Mani pulite è stata come piazzale Loreto, sembra di vedere la storia in modo capovolto. Ma ci sarà un momento per rivalutare questa storia. Ci sarà. Mani pulite non l’ho scoperta io: nasce all’esito dell’inchiesta del maxi-processo di Palermo, quando Giovanni Falcone riceve, riservatamente, da Tommaso Buscetta la notizia che è stato fatto l’accordo tra il Gruppo Ferruzzi e la mafia. Là nasce. E Falcone dà l’incarico al Ros di fare quel che poi è divenuto il rapporto di 980 pagine: che doveva andare a Falcone, ma lui viene trasferito».
A Roma, come direttore generale degli affari penali al ministero di Grazia e Giustizia.
«E il rapporto dei Ros rimane lì, a Palermo, in mano a Pietro Giammanco, che lo mette in cassaforte. Falcone, appena vede tutto questo, ne parla con altre persone. Ne parla con me, perché io stavo lì, al ministero, e lui nemmeno lo conoscevo. Ero perito elettronico, ero stato alla Difesa, mi occupavo di informatizzazione degli uffici giudiziari. Sono stato chiamato lì perché all’epoca nessuno sapeva come funzionava, e invece scoprono che c’è uno che capisce qualcosa di informatica. Così conosco Falcone, la Del Ponte e vengo a sapere di questa realtà. Falcone aveva l’idea che doveva informatizzare questa cosa, quindi già nasce lì».
E l’altra persona a cui ne aveva parlato?
«L’altra era Paolo Borsellino: gli aveva detto di portare avanti quell’inchiesta del Ros. Con Borsellino ci siamo parlati ai funerali di Falcone: nella camera ardente, appoggiati alla colonna. E lui, che nel frattempo evidentemente aveva saputo che Falcone me ne aveva parlato, ripeteva: dobbiamo fare presto, dobbiamo fare presto. Io da parte mia ero partito due o tre anni prima, con Lombardia informatica. Dopo Capaci, Borsellino chiama, si arrabbia come una bestia, si fa dare il fascicolo da Giammanco e si mette a indagare. Chiama Giuseppe De Donno. Borsellino poi viene ammazzato. E io ho sempre sostenuto, ho anche degli elementi, che non è stato ucciso per quel che aveva fatto, ma per quel che doveva ancora fare in quell’inchiesta: non per il maxiprocesso insieme a Falcone, ma perché insieme a Falcone doveva far nascere Mafia pulita».
Mafia pulita?
«Mani pulite non nasce con Mani pulite, nasce come figlia di Mafia pulita. E il mio obiettivo non era scoprire quello che ho scoperto: era arrivare al collegamento al quale già erano arrivati loro, a Palermo. Raul Gardini non si suicida così, per disperazione, il 23 luglio 1993: si suicida perché sa che quella mattina, venendo da me, doveva fare il nome di Salvo Lima, che aveva ricevuto una parte della tangente Enimont da 150 miliardi di lire».
Scusi ma è roba nuova questa?
«Ma no! Ne ho parlato con la procura di Brescia, Milano, ne ho parlato col Copasir, con la procura di Palermo, a Caltanissetta, ma sembra che a nessuno interessi più di tanto, eppure è una storia drammatica».
Cioè, lei sta dicendo: la tangente Enimont era andata un pezzo anche a Salvo Lima, come rappresentante di Andreotti e della mafia.
«Se quel fatto veniva detto, se Gardini parlava, se Salvo Lima non moriva, io avrei potuto avere elementi sufficienti per chiedere al Parlamento di arrestare Andreotti».
Si sarebbero saldate le inchieste, Milano e Palermo.
«Invece all’improvviso le solite manine della delegittimazione mandano una marea di esposti contro di me alla procura di Brescia, che mi costringono alle dimissioni. Ma quando a me rimproverano: “ti sei dimesso”, possibile che nessuno si chieda perché l’ho fatto?».
Veramente ce lo chiediamo da 25 anni.
«Sì, ma è da 25 anni che lo racconto alle autorità giudiziarie. Ma a quanto pare a nessuno fa piacere la mia risposta: era una scelta di campo. Se non mi fossi dimesso sarei stato arrestato, perché le accuse fatte nei miei confronti lo prevedevano obbligatoriamente: c’era il concreto pericolo di inquinamento delle prove, finché ero magistrato. Dunque a Brescia avrebbero potuto arrestarmi. Proprio nel mentre, io stavo arrivando alla cupola mafiosa grazie alle dichiarazioni che mi aveva fatto il pentito Li Pera su un certo Filippo Salamone, imprenditore agrigentino intermediario tra il sistema mafioso e il sistema imprese-appalti, il nord che veniva gestito soprattutto da Gardini e dalla Calcestruzzi spa di Panzavolta. Insomma Palermo arriva prima di me, nel 1992».
E lei quando ci arriva?
«Io l’anno dopo. Con la morte di Falcone e Borsellino cambio strategia: mi dedico solo alle imprese, perché – mi dico – l’unico modo per arrivare a scoprire le malefatte di Tangentopoli e Mafiopoli è non più passare attraverso il reato di corruzione, ma di falso in bilancio. Cerco di arrivarci da quest’altro fronte: e vado avanti come un treno, fino a quando mi trovo di nuovo allo stesso punto, che è Filippo Salamone. Quando io ri-arrivo lì, scoppia il dossier Achille e tanti altri dossieraggi dello stesso tipo».
E lei si dimette.
«Vengo a sapere molte cose anche io, perché in tutta questa storia ho una persona che mi sta idealmente vicina: Francesco Cossiga. Fin quando c’è stato lui sono stato rispettato dalle istituzioni».
Ma lei pure era un confidente di Cossiga, no?
«Eh sì, non solo di Cossiga se è per questo. Di questa storia sono due le persone con cui interloquivo: uno era Cossiga, l’altro Montanelli. La può raccontare, se vuole, Vittorio Feltri, che ogni tanto era presente».
Sta raccontando Mani pulite e Palermo come un’unica storia.
«Ma è così, una storia unica».
Mentre, nella percezione del 1992-93, il pool di Milano si occupava dei partiti, e loro si occupavano della mafia. Lei si occupava di Craxi, loro di Andreotti.
«Tutti dicono che ho fatto Mani pulite per mettere sotto processo la Prima repubblica. Io invece ho processato una persona sola: Cusani. Gli altri erano indagati per reato connesso. Il vero casino nasce quando io faccio il grande errore di non fidarmi di Gardini. Perché io capisco – lo capivo perché già lo sapevo – che dovevo arrivare a Gardini: con lui avrei chiuso il cerchio».
Se Gardini non fosse morto, quello invece che il processo Cusani sarebbe stato il processo Gardini?
«No: sarebbe stato il processo Mafia-appalti, Andreotti compreso».
Ma perché non si è fidato di Gardini?
«L’interfaccia tra me e Gardini è un ex procuratore aggiunto di Milano, che era diventato il suo co-difensore. Concordiamo tutto. Cosa Gardini dirà, e il fatto che se ne andrà con le sue gambe, cioè non sarà arrestato. L’accordo è che lui viene alle otto la mattina. Abbiamo la certezza che è all’estero, in Svizzera, quindi per venire da me deve andare a dormire da qualche parte. Per cui io faccio mettere carabinieri, finanza, polizia, a Milano, Roma, Ravenna. Non faccio capire nulla a nessuno. Quello per venire da me deve necessariamente rientrare in Italia: e da allora non mi deve scappare più. Perché anche io lottavo contro il tempo, c’era anche l’ipotesi di farmi fuori – non dimentichiamo. Comunque, a mezzanotte mi chiamano i carabinieri, uno di quelli del capitano Zuliani, e mi dicono: è arrivato a piazza Belgioioso, lo prendiamo? E io: no, mantengo la parola sennò non mi parla più. Poi mi chiedono, e io do, l’ordine formale di non arrestarlo. Se l’avessi arrestato ora sarebbe ancora vivo. Ora non so più quello che avrebbe messo per iscritto davanti a me. Alle otto mi telefona l’avvocato di Gardini, dice “stiamo arrivando”. Lui era già vestito. Da quanto riferisce il maggiordomo, si affaccia e vede i carabinieri. E pensa che io l’ho tradito. A quel punto: bum, è un attimo. Si è ammazzato perché era convinto che lo stavo arrestando».
Così si blocca l’indagine.
«Devo individuare un altro imprenditore del nord che potesse avere un qualche collegamento con le persone potenti del sud. Mi imbatto nel frattempo in imprese che fanno capo al Gruppo Berlusconi. Ma non arrivo a Silvio, arrivo al fratello Paolo che non c’entra nulla con le vicende su cui stavano indagando in Sicilia. Poi arriviamo anche a lui, con l’avviso di garanzia a Napoli. Dopodiché si ferma tutto. Non perché entra in gioco Berlusconi, ma perché entra in gioco la raffica di esposti nei miei confronti su cui si mette in moto la procura di Brescia che rigirerà la mia vita come un calzino. Ma alla fine tutte le inchieste verranno archiviate e io prosciolto. Mi rimane ancora oggi l’amaro in bocca per l’attività investigativa nei miei confronti portata avanti in particolare dall’allora pm di Brescia Fabio Salamone che poi sarà sanzionato dal Csm, in quanto non avrebbe potuto indagare su di me proprio perché io prima avevo indagato su suo fratello Filippo Salamone. Ma questa è un’altra storia e lasciamola lì».
Chi ha comandato i dossieraggi di cui parla?
«Sono cose che posso dire solo all’autorità giudiziaria, come peraltro ho già fatto più volte!».
E Filippo Salamone?
«È morto. Questo è il dramma, perché l’errore è stato commesso a mio avviso a Palermo. Due volte. Il primo errore lo commette l’ex procuratore Giammanco, quando chiude a chiave in un cassetto del suo ufficio il dossier del Ros del 1991. Il secondo lo commetto io, quando mi lascio convincere a trasferire gli atti riguardanti le vicende mafiose a Palermo per competenza territoriale».
E come?
«Perché a Palermo, nonostante gli ottimi rapporti con il procuratore Caselli e alcuni sostituti come Ingroia, c’erano altri sostituti nel pool, un altro ambiente, di cui il Ros di De Donno evidentemente si fidava poco. Quindi un bel giorno l’allora capitano mi porta a Regina Coeli, a parlare con l’ex capo area della Rizzani De Eccher in Sicilia, Giuseppe Li Pera. Il quale mi tira fuori Filippo Salamone. A quel punto, mentre discutiamo su chi deve procedere, arrivano i dossieraggi a Brescia e io sono costretto a dimettermi. In pratica quando il fascicolo riguardante Filippo Salamone arriva a Palermo, egli riesce subito a patteggiare, previa derubricazione della associazione a delinquere a stampo mafioso con quella semplice. Resta il fatto che il mandante dell’azione di dossieraggio nei miei confronti manca».
E lei sa chi è?
«Certo. Più esattamente: non lo so, me lo doveva dire Gardini. La cosa più drammatica è che io al Copasir sono stato due giorni interi a spiegare i fatti, hanno fatto la relazione, una nel 1995 e una nel ‘96, ma il mio interrogatorio è ancora lì fermo e nessuno prosegue quegli accertamenti che pure si erano impegnati a fare . E io da quel giorno ogni legislatura scrivo, scrivo a ogni capo dello Stato, ho scritto sempre a tutti. Per favore volete continuare? Ed è un peccato, perché tutti hanno visto la Sicilia come una realtà solo mafiosa e Milano come una realtà solo imprenditoriale. Seconda cosa: non è vero che Mani pulite sia partita solo da Milano. C’era già il rapporto del Ros del ‘91, quello messo in cassaforte dal procuratore di Palermo Giammanco, dove veniva raccontato quello che io ho scoperto anni dopo».
Raccontata così, sembra tutta un’altra storia.
«Ma io ho vissuto tutto un’altra storia rispetto a quella che ho letto sui giornali».
E Craxi? Tutta la parabola di Mani pulite vive dell’incontro tra voi due.
«Nell’immaginario collettivo sì, ma nella realtà io non ho mai avuto un rapporto con Craxi. Io miravo all’ambiente malavitoso che girava intorno ad Andreotti».
E invece ha pescato Bettino.
«Che era uno dei tanti».
Vuol togliergli pure il ruolo di protagonista?
«Lo sanno anche le pietre: Andreotti è stato prescritto, fino al 1980, non è che è stato assolto. E dall’altra parte ci stava il sindaco, Vito Ciancimino, e Salvo Lima. Quindi, voglio dire: quello era il potere vero. Craxi era l’emergente, quello che faceva parte della Milano da bere. Nell’89 dal maxi-processo di Palermo si discute dell’ambiente che gravitava intorno alla Dc. Poi, per l’amore di Dio, la mia persona viene sempre accostata a Craxi: ma le indagini non erano finalizzate a lui come puntiglio personale».
Il leader del Psi aveva centralizzato il finanziamento, aveva un canale suo.
«Questo dovete smetterla di dirlo. Il finanziamento passava attraverso Vincenzo Balzamo. Mentre i soldi trovati in Svizzera a nome di Giorgio Tradati, amico d’infanzia di Bettino, non era finanziamento: era corruzione. Craxi faceva come tanti: siccome quello era il sistema, una quota se la tenevano per loro e ci facevano quel che ci dovevano fare, a fini personali. Era un normale politico come tutti gli altri, che ha fatto quello che hanno fatto anche gli altri. Non è che ha agito diversamente. L’ha ammesso anche lui. Non c’è una differenza, non fatelo più grosso di quello che è».
Che cosa pensa del suo famoso discorso alla Camera?
«Lo ritengo solo una furbata politica dell’ultimo momento, quando in Aula ha detto: assumiamoci la responsabilità di come funzionano i finanziamenti ai partiti. Se l’avesse detto quando era al governo, avrebbe detto una cosa giusta. Se lo dici il giorno dopo che ti hanno beccato, non sei più credibile, soprattutto sembra solo un tentativo di difesa personale. Bettino Craxi ha fatto un grosso discorso politico, però l’ha fatto il giorno dopo che l’abbiamo scoperto. Quindi quando si parla di questo suo grande gesto di responsabilità: ne prendo atto, tenendo presente che lo ha fatto quando è stato preso con le mani nella marmellata».
Perché nell’immaginario collettivo ci siete, però, voi due, Tonino e Bettino?
«Perché l’immaginario l’ha creato Craxi, i craxiani soprattutto, creando l’idea di Mani pulite come operazione politica. Ma non lo è stata, men che meno nei confronti del Psi».
Dicevano che lei era amico dei socialisti.
«Ed era un paradosso. È vero: ho frequentato quell’ambiente, era l’unico modo per sapere. Il primo lavoro che ho fatto, all’arrivo in polizia a Milano, è stato l’infiltrato».
E prima, al ministero della Difesa?
«Ci stavo da perito elettronico, che poi è tutto quel film che si sono inventati Craxi e il mondo socialista, e poi anche Berlusconi: il telefilm di me agente dei servizi. Ma non ci azzecca niente. È vero, quando ero militare feci un concorso, poi andai all’estero, poi vinsi, ritornai in Italia e andai a lavorare al ministero della Difesa. Lì, visto che ero l’unico perito elettronico tra i liceali, mi hanno messo a farei controlli su taluni apparati elettronici degli aerei F104, quindi mi mandarono a fare i controlli nelle aziende militari che facevano questi collaudi. Mi occupavo della parte prettamente elettronica, non è che facevo l’agente segreto: controllavo i giroscopi per i sottomarini».
Che anni erano?
«Avevo 24 anni, sarà stato il ’74, ’75. È chiaro, quello è un ambito militare, altamente “controllato” reciprocamente da tutte le superpotenze. Però io ero un semplice impiegato impegnato nei collaudi di apparati elettronici e basta. Erano le prime mosse di informatica che stavo apprendendo: mi ha permesso di capire il meccanismo, i codici, capire poi tante cose. Anche come funzionava quell’ambiente, certo. Ma non ho mai fatto parte dei servizi, non so nemmeno cosa sono i servizi».
Tutte montature di Craxi?
«Io non ho avuto mai nulla contro questo signore. Sono i craxiani, prima e più di lui, che hanno montato la storia che ce l’avevamo con loro. Ma in realtà non è cosi. Non c’era proprio niente. Hanno creato l’idea che questa fosse una operazione politica gestita dal partito comunista, oppure gestita dagli americani. Due cose diverse. Due balle mostruose».
Peter Semler, console americano di Milano, dice che già nel 1991 gli aveva detto che avreste arrestato Chiesa e sareste andati su Craxi.
«È una invenzione totale. Nel ’91 io Mario Chiesa nemmeno sapevo che esistesse. È vero che io stavo facendo delle indagini molto delicate, dall’89, dal ’90, ma rispetto a una realtà che conoscevano pure le pietre. Per me Craxi è uno dei tanti, lui la gira sul politico inventandosi, facendo scrivere questa storia dei servizi, dossieraggi, che non ci azzecca niente».
Ma al consolato ci andava? Nella sua storia americana non c’è solo Semler, c’è molto di più.
«Ah già! Quella cena famosa di Natale al consolato dove c’era Bruno Contrada, il capo dei servizi, c’era il responsabile dei servizi americani, il console americano, l’allora colonnello Leonardo Gallitelli. Cosa succede quel giorno? Per me quello era un pranzo natalizio in una pausa tra gli interrogatori. C’era un mare di gente e mi avevano messo al tavolo centrale, col console americano, francese e non so chi altro. Quindi quella foto che poi è girata nelle redazioni dei giornali sembra il pranzo del complottista. Ma escludo che quel pranzo sia stato fatto per fini complottisti. E, se pure lo fosse, certamente non col concorso mio e nemmeno con il concorso di Gallitelli».
Sta suggerendo che qualcuno l’abbia usata?
«Che qualcuno possa aver usato il mio nome io non lo so, me lo sono chiesto anche io mille volte, e non me la sento neanche di escluderlo. Ma io non ho mai avuto a che fare con un solo agente segreto in vita mia. Io sapevo solo che c’era questa situazione ambientale in Italia, grossa come una casa, sapevo del maxi processo, sapevo che c’era questo rapporto del Ros. Sapevo che questa era una grande inchiesta che si poteva fare, e ho cercato di farla. E di Craxi, in questo momento l’unica cosa che ricordo è che quando l’ho visto in tv parlare alla Camera, ho detto: “Va sentito subito, perché è una confessione. Ora lo chiamo”».
Fonte: L’Espresso


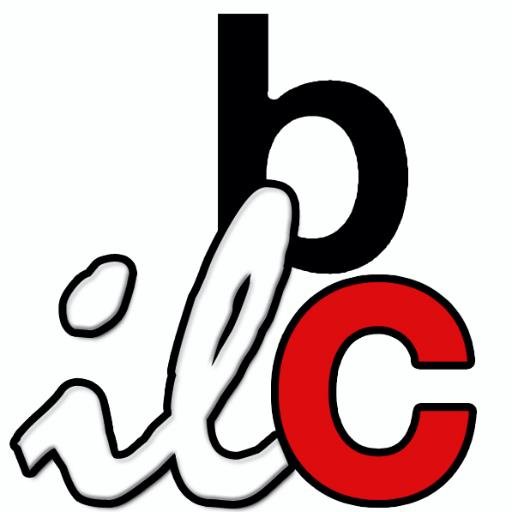









0 Comments