Alle aree interne il sapere migliore: dai paesi come spazi di vita, alle comunità reali. Bisogna avere una conoscenza profonda dei luoghi per evitare di musealizzarli

di Maria Fioretti
Ripensare in maniera critica l’idea dei margini, decostruire gli immaginari e guardare con consapevolezza alle fragilità e allo spopolamento, evitando il pensiero unico tanto quanto l’approccio mordi e fuggi: ci siamo confrontati con la professoressa Letizia Bindi – antropologa e direttrice del Centro BIOCULT all’Università del Molise – su piccoloborghismo e mondo rurale, rigenerazione e conflittualità.
Ragionare di comunità criticamente chiede di ripensare l’idea stessa di margine, di osservare i luoghi, i legami sociali col territorio e tra le persone: Letizia Bindi ci aiuta ad aprire gli occhi e ad invertire lo sguardo, in questo confronto sulle insidie retoriche della rigenerazione territoriale. Oltre le favole raccontate, attraverso un’analisi lucida e rigorosa di quello che un paese significa.
Direttrice del Centro BIOCULT – sul patrimonio bio-culturale e lo sviluppo locale – all’Università degli Studi del Molise, Letizia Bindi insegna Antropologia Culturale e Sociale. È stata Visiting Scholar in varie Università europee in Spagna, Francia, Polonia, Emirati Arabi. È membro delle maggiori società di studi antropologici italiane, europee e americane e partecipa ai Comitati Editoriali di numerose riviste scientifiche e collane di studi demo-etno-antropologici.
Ha collaborato dal 1991 con la RAI (Radio Televisione Italiana) come autore di trasmissioni radiofoniche di interesse culturale e ha realizzato studi sugli Archivi delle Teche RAI per quanto riguarda l’immagine delle comunità locali nella rappresentazione dei media italiani. Nel 2009 ha ricevuto il Premio “scanno” della Fondazione Tanturri per gli Studi Antropologici e Tradizioni Popolari.
Coordina vari progetti internazionali tra il Progetto Erasmus Capacity Building ‘EARTH – Education, Agriculture, Resources for Territories and Heritage’ (con 12 partner provenienti da Francia, Spagna, Argentina, Paraguay e Bolivia) e il Progetto di Ricerca Italo-Argentino “TraPP. Trashumancia y Pastoralismo como elementis del Patrimonio Inmaterial” (supportato da CUIA/CONICET). È membro di Riabitare l’Italia, di Rete APPIA per la Pastorizia e di SNAP (Scuola Nazionale di Pastorizia).
Piccoloborghismo , cominciamo da qui…
«Da antropologa guardo all’insieme di narrazioni e riflessioni che si stanno sviluppando sul tema delle aree interne, fragili, spopolate, marginali e su tutto ciò che ne consegue. In primo luogo come un processo di nuova progettazione di territori che storicamente sono stati oggetto delle discipline demo-etno-antropologiche nelle quali mi sono formata, ma anche come un grande fascio di narrazioni. Per la prima volta siamo di fronte ad una fase in cui – dopo decenni di pensiero intorno al mondo rurale come un mondo che appassisce, si restringe, perdendo vitalità – si comincia a pensare che per questi territori ci sia una nuova opportunità.
Ci sono degli elementi di realtà, al tempo stesso ce ne sono alcuni di rappresentazione e per l’antropologia diventa interessante capire chi racconta, con quali obiettivi. Tra queste forme di narrazione che si sono diffuse, ce ne sono alcune di particolare successo: una è certamente quella relativa ai borghi che è diventata mainstream. Tutti ne parlano, si è imposta la retorica dei piccoli villaggi, il ragionamento sulla rigenerazione che è un pensiero che abita anche una serie di pratiche molto concrete, dall’urbanistica al restauro, con una patrimonializzazione molto forte dei centri storici: questo sposta l’attenzione su una forma museale dei piccoli paesi rispetto invece alla loro reale vitalità. Troppo spesso si pensa ai centri storici come luoghi da cui espungere ogni tipo di elemento di trasformazione e modernizzazione, musealizzati e pronti per essere trasformati in oggetti di consumo per un certo turismo urbano».
Qual è il rischio?
«Secondo retoriche abbastanza diffuse il mondo rurale viene interpretato come una specie di buen retiro, di posto per il riposo domenicale in cui andare a cambiare aria. In questo senso io parlo di “piccoloborghismo”. Rischiamo in qualche modo di guardare al recupero di queste aree in una tensione con le città, pensando erroneamente che sopravvivono perché ci sono i turisti e i curiosi dalle città a visitarli. Invece bisognerebbe ribaltare lo sguardo. Non pensare più ai paesi come a qualcosa di esclusivamente pro-turistico, ma come spazi di vita concreta di persone reali. In questo senso sarebbe importante partire da una place citizenship, da un esercizio pieno di cittadinanza dei luoghi, da una titolarità di chi ci abita e deve riuscire ad esprimere ciò che vuole fare, per rendere abitabili quegli spazi e di conseguenza a renderli abitabili anche per un turismo sostenibile».
Comunità e paesi, reali o immaginati: esiste una giusta rappresentazione?
«Comincerei a decostruire proprio il termine, pensare in termini di comunità significa affermare che in posti piccoli la popolazione è accomunata da un pensiero unico. In realtà esistono conflittualità, frizioni, differenze, una stratificazione sociale, economica, di genere, generazionale molto forte che abita anche i piccoli paesi e non possiamo esimerci dal leggere questa complessità. Se ci limitiamo a semplificare le comunità, finiscono sotto la lente che ne ingrandisce i tratti arcaici, in linea con uno sguardo esotizzante che vuole le comunità rurali uniche, poetiche, antiche, armoniose, un orientalismo o un esotismo interno, come lo ha definito Jane Schneider.
Molto ottocentesco in fondo come immaginario; in realtà i contadini fanno i conti con le costrizioni e contrizioni della politica agricola comune, con i Piani di Sviluppo Rurale, gli abitanti delle aree spopolate e periferiche – altra nozione da ripensare – si confrontano con la SNAI. Si tratta di luoghi densi, in alcuni casi, che provano a ripensare le economie, che ragionano in ottica di comunità energetiche, di rivitalizzazione culturale dei paesi, di innovazione sociale in agricoltura: per questo c’è una necessità di un sapere acuto e puntuale, di una etnografia delle comunità, dialogando con loro per progettare percorsi di sviluppo sostenibile, fuori da logiche “sviluppiste”, di crescita progressiva, cercando di uscire dalla logica del progresso scorsoio di cui parlò Andrea Zanzotto, secondo cui più il progresso fa avanzare, più ci stringe alla gola. C’è bisogno di immaginare i processi di cambiamento in armonia con le esigenze dei territori e delle persone, nelle loro molte componenti. Così si evita di calare dall’alto le soluzioni».
Perciò anche quella di una riattivazione dal basso delle comunità potrebbe risultare una retorica?
«Quando si parla di conoscenza profonda dei luoghi, di deep mapping, si intende la necessità di avere una maggiore comprensione di quello che si fa sui territori: è fondamentale, ad esempio, la multidisciplinarietà e soprattutto il dialogo costante tra sistema esperto e comunità. Tante discipline oggi parlano di etnografia – metodo tipico dell’antropologia – ovvero il lavoro di campo. Perché si ha un gran bisogno di affermare che le proprie osservazioni e le proprie risoluzioni sono basate su una conoscenza profonda.
Ma l’etnografia richiede tempo ed energie, le etnografie non finiscono mai e soltanto uno sguardo di lungo corso permette di avere sulle località e sulla collettività la giusta considerazione. Altrimenti è una survey, un approccio mordi e fuggi che in realtà significa lavarsi la coscienza, dirsi di aver ascoltato per un po’ il territorio, rifilando poi una conclusione buona per tutti».
Quello delle aree interne è diventato un trend – complice la pandemia – con inviti a riabitare, al southworking, spingendo sull’acceleratore del piccolo è bello: secondo lei la conseguenza è stata una certa improvvisazione e anche l’avvicendarsi di professionalità dubbie in tema di marginalità?
«La confusione multidisciplinare non mi preoccupa, quello che mi fa temere invece è l’uso predatorio delle categorie. Identità, comunità, spirito dei luoghi, coscienza dei luoghi, se ne parla come se fossero nozioni facili, con quest’approccio easy to go, mentre all’interno di queste nozioni ci sono pratiche, un senso dell’appartenere, la fatica del restare. Tutto questo ha bisogno di essere calato in una modestia della ricerca, non si può pensare di arrivare a soluzioni semplici in poco tempo.
Quello che mi spaventa rispetto a figure che si incaricano di trainare un processo territoriale è che lo facciano con leggerezza, nel senso di distrazione e superficialità. Di facilitatori e community manager si discute da tempo nell’ambito delle strategie di sviluppo sostenibile: possono avere un ruolo importante di mediazione e dinamizzazione territoriale e ci abbiamo riflettuto a lungo nel progetto EARTH che coordino con altre Università europee e latinoamericane che contiamo dall’anno prossimo di far divenire un Joint Master Degree sui temi dello sviluppo sostenibile delle aree fragili, attraverso un recupero critico dei patrimoni bioculturali locali.
È necessario – a questo punto – smettere di pensare che le aree interne debbano ricevere cascami del sapere migliore, come accade da sempre: la provincia prende i resti del sapere più avanzato che circola nelle città. Questo, piuttosto, è un tempo in cui queste aree meritano il nostro sapere migliore: da un lato perché meritano di rigenerarsi, dall’altro perché la loro rigenerazione serve anche alle città che stanno affogando in una mare di invivibilità e saturazione, che hanno bisogno di campagna e montagna per produrre le materie prime. È eticamente giusto ed è utile, abbiamo bisogno di progettare con il sapere più avanzato perché stanno consentendo al Paese e alle città di vivere e lo consentiranno sempre».
Il sapere migliore, sarebbe il percorso più bello e auspicabile. La realtà però ci dice che sempre più spesso si sceglie la strada facile, quella che passa – tra le altre cose – per la vendita del patrimonio. È una soluzione quella delle case a 1 euro? Per fare giusto un esempio…
«È una svendita, non è certo pretendere il miglior sapere possibile. Non si rigenera così, come non si rigenera attraverso un uso indiscriminato dei sistemi di accoglienza emergenziale dei migranti nei piccoli paesi.
Per la stessa ragione per cui un tempo sono andati via gli autoctoni, andranno via anche i richiedenti asilo e i rifugiati, è solo l’altra forma di un parcheggio. Invece dovremmo riflettere seriamente sulla rigenerazione attraverso l’integrazione migrante, che sarà una delle soluzioni crescenti per riabitare i paesi, ma dobbiamo farlo in una chiave di sostenibilità. Nelle esperienze di innovazione sociale in agricoltura – dove vi sono lavoratori anche giovani che vengono da aree di migrazione – alcuni saperi che loro detengono si rivelano fondamentali e danno vita ad un reale interscambio.
Quello che proponiamo adesso è di salvarci nel breve termine collocando nei paesi qualche quota di migranti per tenere aperta la scuola o la bottega di alimentari, la soluzione non è questa. Serve una progettazione che renda riabitabili i luoghi per i migranti e per gli autoctoni, serve ripensare alla produzione, serve che questi territori tornino a produrre una agricoltura, che si ricominci a fare allevamento, perché avere dieci pecorelle che si spostano su un tratturo per fare scena in favore dei turisti, non significa far rivivere una pratica».
Sul finale proviamo a fare sintesi: decostruire gli immaginari consolatori della località e guardare etnograficamente alle fragilità e allo spopolamento, come si realizza questo intento concretamente?
«Guardare con occhi nuovi e da vicino a questi fenomeni è possibile solo stando nei paesi concretamente, osservando le pratiche minute, mettendo mano ai processi. Io non sono per la sola etnografia, ma per un approccio in cui l’etnografo si faccia carico di interpretare anche le grandi strategie.
Ogni luogo piccolo è dentro un flusso di eventi grandi, ogni piccolo paese dell’Italia è dentro un Gal, una strategia Leader, una strategia Snai, beneficia – direttamente o indirettamente – di fondi europei, viene coinvolto in processi che in qualche modo utilizzano la dimensione montana per ottenere finanziamenti. Quello che rivendico con forza è la possibilità di guardare a tutto questo essendo consapevoli e soprattutto sforzandosi di restituire al territorio e consentendo alla cittadinanza di esprimersi in merito ai processi di sviluppo e rigenerazione territoriale.
L’etnografo sta, guarda da vicino e da lontano – per citare Lévi-Strauss – e si impegna a restituire al territorio che gli dà le informazioni il suo sguardo critico su quel luogo, sulle dinamiche collettive che osserva, sulla sua posizione persino nel campo. Quello sguardo caleidoscopico lo riguarda, potremmo dire, e al tempo stesso offre l’opportunità alle comunità con cui lavora di riguardarsi e progettare diversamente il proprio futuro».
Fonte: Orticalab


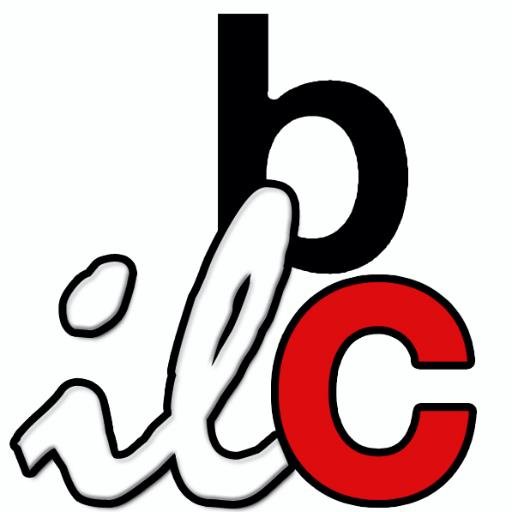








0 Comments