“La potenza della vita nell’orrore della guerra”, la retrospettiva del fotografo Don McCullin in esposizione a Roma

di Marinella Ciamarra
Domenica scorsa, 21 gennaio, le Associazioni fotografiche attive in Molise, Vivian Mayer e Sei Torri, hanno organizzato un pullman da Campobasso che è partito di buon mattino in direzione Palazzo delle Esposizioni a Roma che ospita, dal 10 ottobre scorso fino al 28 gennaio prossimo, la prima grande retrospettiva in Italia e, ad oggi, la mostra più ampia mai dedicata al fotografo britannico di fama internazionale Don McCullin.
La mostra si riallaccia idealmente, ampliandola, all’antologica della Tate Britain curata da Simon Baker nel 2019, poi replicata alla Tate Liverpool nel 2020. Oltre a ripercorrere i momenti più significativi del lavoro di McCullin, presenta la serie dedicata all’Impero romano, in particolare ai resti nell’area del Mediterraneo meridionale, avviata negli anni Duemila, che lo stesso autore considera un punto di arrivo nel quale si sovrappongono, fondendosi, i temi cardine della sua fotografia:
“Quelle colossali strutture di pietra di epoca romana risalenti a duemila anni fa mi riempivano di meraviglia, poi mi sono reso conto di come erano state realizzate. Tramite la crudeltà. Tramite la malvagità e la schiavitù. La loro incredibile realizzazione era frutto della brutalità. Mi hanno fatto pensare ai campi in Germania dove le persone lavoravano fino a stramazzare a terra. Nello stesso momento in cui la guardavo questa meraviglia, mi veniva sottratta. Mi sembrava quasi di riuscire a sentire le grida delle persone schiacciate sotto quei pietroni enormi.”
La retrospettiva segue un ordine cronologico e ripercorre tutte le fasi della vita dell’autore:
dalla nascita a Finsbury Park, Londra, alle varie missioni del periodo tra il 1966 e il 1984, come la guerra in Biafra, il Congo Belga, i troubles in Irlanda del Nord (il periodo di violenze tra indipendentisti e unionisti nordirlandesi in cui, per oltre trent’anni, tra la fine degli anni Sessanta e la fine dei Novanta, vennero compiuti attentati terroristici in tutto il paese), il Bangladesh, la guerra civile del Libano, El Salvador, l’oppressione della Palestina, le guerre in Cambogia e in Vietnam (dove tornò ben 15 volte), fino all’ intenzione di abbandonare la fotografia di guerra per dedicarsi al paesaggio inglese, continuando tuttavia a girare il mondo e a fotografare, visitando l’India, la Siria e molti paesi del continente africano, dove ha realizzato un importante lavoro documentario sulla crisi dell’AIDS. McCullin è oggi riconosciuto come uno dei più grandi fotografi del mondo. Molte delle sue foto di guerra sono delle vere e proprie icone.
Ha iniziato la sua carriera con una reflex biottica Rolleicord negli anni Cinquanta a Londra, e le sue foto, che ritraevano con una certa crudezza amici ed eventi locali, hanno subito suscitato l’interesse dei direttori delle riviste per il suo innato talento, procurandogli lavoro tra i giornali all’epoca all’avanguardia del giornalismo critico e di inchiesta, che pubblicavano ampi reportage riccamente illustrati come The Observer e The Sunday Times Magazine.
Nei primi anni Ottanta, Harold Evans, leggendario direttore del Sunday Times, si dimise a causa di divergenze sull’indipendenza editoriale quando Rupert Murdoch assunse il controllo del giornale. Il sostituto di Evans, Andrew Neil, licenziò McCullin, il quale lamentava la mancanza, da parte del giornale, di una seria copertura degli eventi internazionali e sociali sotto la nuova direzione. Il desiderio di rappresentare le ingiustizie della terra che lo accompagna dall’inizio del sua carriera ha sempre alimentato il suo vagare nel mondo, tra gli umiliati e offesi della terra, i derelitti, i poveri. Una sovrastruttura che marxisticamente nasce dai luoghi in cui è cresciuto, Finsbury Park, a Londra, che allora era un quartiere operaio molto povero. Insieme alla madre, al padre e al fratello, dormiva in una stanza buia di un seminterrato. E questo spiega come mai le ragioni della sua presenza come fotografo documentarista siano di natura emotiva, perché McCullin sa esattamente cosa provano le persone che fotografa.
La povertà è un mostro che ti entra dentro e penetra tutte le fibre del tuo essere. Il dolore diventa cronico. E non c’è differenza, come lui stesso sottolinea, tra i morti ammazzati in Vietnam o nelle decine di guerre nelle quali McCullin è stato in prima linea, e gli affamati delle guerre sociali in corso ogni giorno nel quartiere povero sotto casa propria. Anche lì ci sono guerre in corso, non occorre andare all’altro capo del mondo in aereo dove ci sono bombe e pallottole. Ci sono guerre sociali degne di altrettanto interesse. E tuttavia McCullin la guerra l’ha vissuta. E l’ha vissuta da protagonista, costantemente accompagnato da quel senso di colpa che non lo abbandonerà per tutta la vita:

“La donna morta è stata fuori dall’ospedale allagato e la barella posata per terra accanto alla tenda dove tenevano i cadaveri. I familiari aspettavano dall’altra parte e si sono sdraiati vicino a lei mentre scattavo le foto. Gli sembrava impossibile che la loro madre fosse morta. Io avevo l’impressione di usare la macchina fotografica come qualcosa dietro cui nascondermi. Stavo lì, sentendomi meno umano, un corpo scarnificato, come un fantasma presente ma invisibile. Non hai nessun diritto di essere qui, mi dissi, avevo un groppo in gola e stavo per scoppiare in lacrime”. Ma come racconta in un altro scritto al giornalista Mario Calabresi, “da dove vengo io, a Finsbury Park, non si piange, perchè è un segno di debolezza e sconfitta. Così tutti quegli incubi mi seguirono ogni notte nel sonno.”
Mc Cullin dorme per settimane sotto le bombe, per terra, in mezzo ai morti.
Schiva un proiettile che lo stava per colpire grazie alla sua Nikon.
Per anni, per gran parte della vita, non assiste che a dolore, esplosioni, morte.
Le sue immagini spesso sono di atrocità e riproducono fedelmente quelle morti, quel sangue.
Ma il suo intento è dar voce a coloro che in quelle foto compaiono, vuole che quella voce persuada le persone ad indugiare innanzi alle sue foto, affinchè chi le guarda sia consapevole di un obbligo, perché il rischio di una inerte acquiescenza è sempre in agguato.
E questa è il vero nemico contro cui bisogna lottare: l’indifferenza, uno dei grandi mostri dell’umanità. Troppo scontato citare Gramsci, certo. Ma doveroso. Perché l’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. E genera schiavitù. Laddove tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. Ma nel momento in cui si prende coscienza della propria volontà, della parte che si sceglie di avere nella società, di dove schierarsi, ogni cosa che succede non è più dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini.
E le immagini di Mc Cullin hanno proprio questa finalità.
E questo effetto, in chi sa guardare, in chi sa vedere dietro quei morti, dietro quel dolore, dietro quelle ingiustizie in ogni spazio e tempo, dietro quelle storie individuali e collettive. Quelle immagini inducono a schierarsi. A prendere posizione. A non essere indifferenti. A dire che la guerra o la povertà o la disuguaglianza sociale sono una montagna di merda.
E bisogna denunciare, sempre. Attraverso la lotta. Che può essere individuale o collettiva, poco importa. Ma deve essere viva, sempre.
“Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia compiuta verso chiunque in qualsiasi parte del mondo”, diceva il Che.
È la qualità più bella di un rivoluzionario. Di un partigiano. Di un cittadino. Di un essere umano.
È il senso dell’humanitas a cui aspiravano i latini.
È l’empatia.
È il cum patior, il soffrire con, la compassione di kunderiana memoria, tra le pagine più belle de “L’insostenibile leggerezza dell’essere”.
La fotografia, l’arte, possono svolgere un grande ruolo sociale.
Le foto di McCullin rendono onore a ciascun essere umano massacrato dall’idiozia della guerra.
A ciascun povero oppresso dal giogo del potere.
 Gridano alla Vita, proprio perché mettono in scena la Morte.
Gridano alla Vita, proprio perché mettono in scena la Morte.
Nell’ultima parte della sua vita, McCullin si rifugia nei paesaggi del Somerset per lenire la sofferenza delle sue esperienze di guerra:
“Allora, dappertutto c’è colpa: colpa perché non sono religioso, colpa perché sono stato capace di andarmene via mentre quest’uomo moriva di fame o veniva assassinato da un altro uomo con una pistola. Ed io sono stufo di sentirmi in colpa, stufo di dire a me stesso: “Non ho ucciso quell’uomo nella fotografia, non ho fatto morire io di fame quel bambino”. È per questa ragione che voglio fotografare paesaggi e fiori. Mi sto autocondannando alla pace”.
Ma la pace, per chi ha vissuto la guerra, non esiste se non nell’utopia. Lo spirito del fotografo rimane quello di sempre, il sentire su di sé il dolore dell’altro, la predilezione per gli oppressi e l’idiosincrasia per le ingiustizie sociali:
“La mia fotografia è politica, perfino il panorama inglese che ritraggo dalla finestra di casa ha un valore politico: difendere dagli speculatori edilizi l’ultimo pezzo di territorio vergine che abbiamo in Inghilterra.”
I paesaggi rappresentati sono cupi, non hanno nulla di idilliaco o bucolico o pacifico.
Portano al loro interno quella sofferenza fortemente sentita, il sangue versato, le esplosioni, la Morte. Il conflitto dentro e fuori di sé.
Il senso di colpa non è esaurito.
Il ricordo è più vivo che mai.
“A volte, mentre cammino nelle brughiere dello Yorkshire o nell’Hertfordshire, il vento passa sferzante tra l’erba e mi sembra di essere sulla strada di AnLoc in Vietnam, e di sentire i gemiti dei soldati sul ciglio. Mi pare di udire in lontananza i mortai da 106 mm. Non mi usciranno mai dalla testa.”
La memoria è una condanna che non lascia scampo.
L’inconscio, un abisso senza fondo.



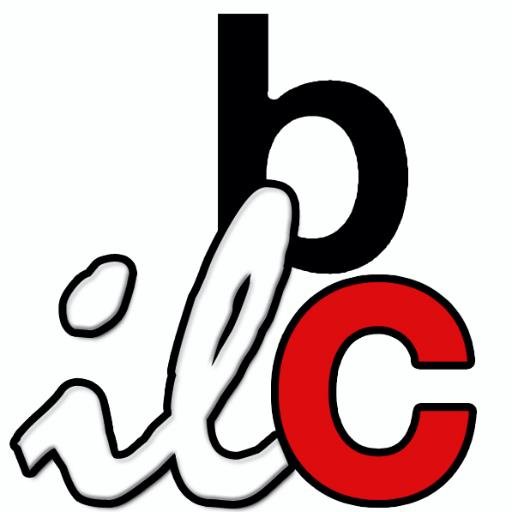




0 Comments